best unofficial Bob Dylan site

MAGGIE'S
FARM
sito
italiano di Bob Dylan
creato da Michele "Napoleon in rags" Murino
curato da Mr.Tambourine
" Volevo soltanto una canzone da cantare , e arrivò un certo momento in cui non riuscii a cantare niente . Così dovetti cominciare a scrivere ciò che volevo cantare perchè nessun altro scriveva ciò che volevo cantare . Non riuscivo a trovare niente di buono , ovunque cercassi , se ci fossi riuscito forse non avrei mai cominciato a scrivere canzoni . (Bob Dylan)
These are the best

that I've ever heard
Parole nel vento
A cura di Alessandro Carrera
Quelli che............suoniamo Dylan
MAGGIE'S FARM BLACKBOARD
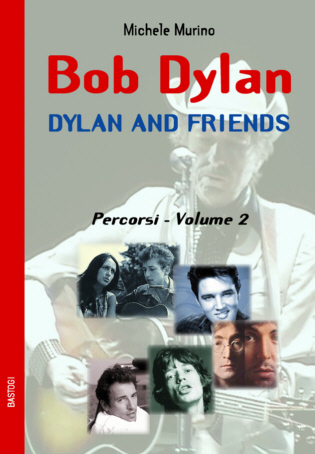
prevista per giugno l'uscita del nuovo libro di Michele Murino - Percorsi vol.2 - DYLAN AND FRIENDS
clicca qui per la scheda del libro
MODERN TIMES, il nuovo splendido album - clicca qui
I'M NOT THERE - ORIGINAL SOUNDTRACK - La recensione Clicca qui
E' uscito il terzo volume della collana "Musica & Parole" (Editrice Bastogi). clicca qui
Tutte le traduzioni dei testi di Dylan clicca qui
Interviste a Bob Dylan clicca qui
Come writers and critics.... saggi e articoli su Bob Dylan clicca qui
UN GIORNO TUTTO SARA' CALMO - spettacolo teatrale liberamente ispirato all'opera di Bob Dylan clicca qui
THE TRAVELING WILBURYS COLLECTION - Clicca qui
WHO'S WHO - Tutte le persone , gli amici ed i personaggi di Dylan clicca qui
BOB DYLAN TIMELINE clicca qui
PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI DEL SITO
VAI ALL'INDICE GENERALE DI MAGGIE'S FARM CLICCANDO QUI
ULTIMA ORA : DYLAN COLPITO DA UNA SCARICA ELETTRICA SUL PALCO DELL' ULTIMO CONCERTO A ZAPATECAS - MEXICO - IL CUORE DELL'ARTISTA AVREBBE CESSATO DI BATTERE IERI NELL'OSPEDALE DOV'ERA STATO RICOVERATO - ( fonte International Press Company of N.Y. ) clicca qui
_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
Alcuni giorni fà dovevo chiamare Michele al cellulare , allora , conoscendo la sua abituale parlantina da fiume Colorado nel periodo della piena , ho chiamato il 4916 , - il suo credito è di 29,60 euro – mi ha informato la vocina , “ Forse ce la faccio “ mi son detto prima di fare il numero.
Dopo gli argomenti tecnici e di varia umanità siamo venuti a parlare della Fattoria e gli ho chiesto speranzoso “ Cosa ne dici se ti intervisto per i lettori ? “ . “ Và bene comincia “ mi ha risposto .
E’ chiaro che i miei 29,60 euri sono andati in fanteria , ma fà niente , ne valeva la pena !!!!!!!!!
L’intervista a Michele “Napoleon in rags” Murino
1) Ciao Michele ,
prima
di ogni altra cosa , perchè hai scelto “Napoleon in rags” come tuo nome
“dylaniano” ?
Mah... Innanzitutto lasciami dire: "'Azzo, intervistato
da MF e soprattutto dal grande Mr. Tambourine (ah, se solo si sapesse
chi sei davvero, tutti si renderebbero conto nelle mani di che grande
uomo - o donna? - sono i dylaniani d'Italia... Maybe someday...)." Ma
veniamo alla tua domanda... Quando ascoltavo le prime volte Like a
rolling stone, al punto in cui quel
bastardo di Dylan cantava: "You
used to be so amused / At Napoleon in rags and the language that he
used / Go to him now, he calls you, you can't refuse..." io sapevo che
stava parlando di me. Non so spiegarlo ma quello ero io, evidentemente
Dylan mi aveva conosciuto e io non lo sapevo, una roba paranormale ma è
così. Quindi la scelta non c'è nemmeno stata in effetti. Io SONO
Napoleon in rags... O meglio ero, visto che sono morto, cioè che è
morto, sì insomma avete capito... dead and gone...
2) Sò che prima di
sentire e amare Dylan eri un Beatlesiano , di Michele-Dylan sappiamo
quasi tutto , e di Michele-Beatles che mi dici ?
Infatti, i Beatles
sono il primo amore. E lo sono ancora ora ovviamente. Quindi non "ero"
un beatlesiano. Ma "sono" un beatlesiano. Credo che, con Dylan, i
Beatles siano stati la massima espressione nel loro campo, non tanto
George o Ringo, per me. Parlo di McCartney e Lennon che ritengo, e lo
ritiene anche Dylan non a caso (lo ha dichiarato in una recente
intervista)
assolutamente irraggiungibili, ineguagliabili,
incomparabili con chiunque, Dylan compreso. Album come Revolver, Rubber
Soul, Sgt. Pepper, ma anche moltissime delle prime cose sono qualcosa
di... come dire... hai presente la citazione cinematografica "ho visto
cose che voi umani..."? Credo che Dylan debba moltissimo ai Beatles.
Così come a Roger McGuinn. E i Beatles devono molto a Bob ovviamente.
Non so chi debba di più all'altro... Credo che nessun artista rock
potrà mai raggiungere le vette di Lennon e McCartney... Dylan c'è
riuscito in altra maniera ma come L/M credo non ne siano mai nati e mai
ne nasceranno... Forse solo Battisti ma è difficile parlare di Lucio in
questo senso perchè è nato in Italia. Fosse stato di lingua
inglese...
Io credo che tra cinquecento anni i giganti della musica della nostra
epoca saranno considerati ancora McCartney e Lennon...
3) Avresti mai
fatto un sito Beatlesiano , magari chiamato “ Strawberry fields “ ?
Credo di no. Per vari motivi. I Beatles mi interessavano quanto Bob ma
su di loro si erano sprecati fiumi di "inchiostro" anche sul Web.
Quello su Dylan l'ho fatto perchè non c'era praticamente niente in rete
su di lui in Italia. Comunque l'avessi fatto l'avrei chiamato magari
davvero "Strawberry fields"... ottima idea... perchè non lo fai tu?...
4) Spiegaci la grande differenza fra Dylan e Beatles ,
non importa se
ti dilunghi , è sempre bello leggere quello che scrivi tu .
Kaspiterina! Una domandina da niente! Comprate il mio nuovo libro "Bob
Dylan Percorsi Vol. 2 - Dylan and friends" e lo saprete...
Comunque al
di là di un discorso critico e storico, almeno per me non c'è una
grande differenza tra Dylan e Beatles... Forse solo che uno è americano
e gli altri inglesi... Ma per il resto la lingua e la stessa... La
categoria pure... La pasta anche... Molte delle radici musicali
comuni... E quello che hanno fatto è sotto gli occhi di tutti e li
accomuna nella grandezza... Forse l'unica differenza è che Lennon aveva
bisogno di McCartney e McCartney aveva bisogno di Lennon. Dylan si
bastava da solo. Forse Paul e John non sarebbero stati così grandi da
soli, ma non abbiamo la controprova...
5) Dylan e la Fattoria ti hanno
dato tanto , tanto lavoro e penso tonnellate di soddisfazioni , potrai
mai dimenticare tutto questo o resterà una specie di marchio a fuoco
inciso sul tuo cuore ?
Dunque... innanzi tutto quello xxx di Dylan non
mi ha mai dato niente... :o) La sua musica sì, e le soddisfazioni di
cui parli certo la Fattoria le dà... ma perchè parli al passato...? Le
soddisfazioni più grandi ovviamente l'interesse e l'affetto dei lettori
e anche di quelli speciali ed eminenti... Pensa che sta per uscire
"Parole nel vento" il volume curato da Carrera con la collaborazione
anche del sottoscritto... Ecco, quella è una soddisfazione... 'Azzo,
collaborare ad un libro con Alessandro Carrera!!!! E' un po' come per
Bruscolotti giocare nel Napoli di Maradona. Ora spero che anche Paolo
Vites mi chieda di collaborare ad un suo libro... su Dylan però eh!?
Comunque come sarebbe se potrò mai dimenticare? Uno al limite può
riuscire a dimenticare una cosa se proprio lo vuole... Ma io perchè
dovrei volerlo?
6) Tu mi hai chiamato al timone della Fattoria , la
cosa mi ha colmato d’orgoglio , che ne pensi dell’idea di rimanere
anonimo dietro il nome di Mr.Tambourine ?
Yeah! Quella è una grande
figata perchè dà mistero alla cosa... Mistero uguale interesse...
Speculazioni, illazioni, ipotesi... Così tutti ti seguiranno anche solo
per capire chi cazpita sei... Grande mossa my friend!!! Ci avessi
pensato io all'epoca... Sarei stato solo Napoleon in rags... Pensa che
bello andare ai concerti e parlare di MF con la gente senza che gli
ignari sapessero di parlare con Napoleon... Questo tu ora lo puoi
fare... Al primo concerto parla con la gente che conosce MF e comincia
a dire cose tipo: "Ma questo Mr. Tambourine fa veramente cagare..."
oppure "Certo che questo Mr. Tambourine è veramente un grande... mica
quell'imbecille di Napoleon in rags..." e poi osserva la reazione...
Istiga, stimola, incita, provoca... Avrai il polso della situazione in
prima persona... Che figata! Avessi potuto farlo io! Comunque credo che
a lungo andare ti faranno tana... ti sgameranno perchè non è facile
riuscire a tenere segreta una cosa così... hai già fatto qualche errore
finora che ha fornito
indizi... e chi legge attentamente può arrivare
a capire chi si cela dietro il tamburino...
7) Tutti vorrebbero sapere
il perchè del tuo abbandono , chi per affetto e chi solo per curiosità
, ma io non te l’ho chiesto per un motivo etico , le cose tue sono tue
e le cose mie sono mie , dimmi le sensazioni che provi ora quando entri
alla Fattoria come un comune visitatore .
La cosa che mi fa ridere è
leggere lettere che parlano di Napoleon come fosse Dylan... Sembra che
l'evento sia paragonabile al ritiro di Dylan dalle scene... Ma suvvia,
suvvia, suvvia... Non è che si sta un tantinello esagerando, ed
eziandio dando troppa importanza al sottoscritto? Comunque davvero
tutti vorrebbero sapere il perchè del mio abbandono? Non "chi siamo, da
dove veniamo e dove andiamo?" Solo quello? Allora dirò che la colpa è
di Anna "Duck"...
8) Tu mi hai dato carta bianca per tutto quello che
riguarda il proseguimento della Fattoria , sapendo che potevo sbagliare
diverse cose e danneggiarla in qualche modo se pur involontariamente ,
questo è stato uno stimolo e un punto d’orgoglio per me , ma il punto
non è questo , il punto è che , non ostante il tuo satirico annuncio di
scomparsa sarai sempre l’anima della fattoria , te ne rendi conto che
non potrai mai distaccarti da lei ?
Ah, beh, ma perchè chi ha detto
che mi sono distaccato? Mi rendo conto di essere l'anima, anche perchè
essendo morto posso essere solo anima... Quindi per risponderti, non mi
distacco. Tu comunque errori non ne puoi fare nè danneggiare MF... se
non ci sono riuscito io non ci riuscirai nemmeno tu... Comunque
cancella quel "carta bianca" che mi fai venire in mente un film di Totò
con Walter Pidgeon e non è il caso, credimi...
9) Se in futuro dovesse
capitarti la fortuna di incontrare Bobby , la prima parola a freddo ?
Non lo so. O "Grazie di esistere" o "Vaffanculo". Una delle due.
10) per chiudere , tornerai ?
E' l'attuale curatore di Maggie's Farm...
che non mi farà tornare! Già, perchè Mr. Tambourine diventerà talmente
amato che un giorno si dirà: "Michele Murino chi?", "Quale Napoleon in
rags?", un po' come oggi si dice, chessò: "Pete Best? E chi è?"
Comunque se tornerò, tornerò come un ladro nella notte...
Be ready, for
you know not the hour in which I come... Allora grazie per
l'intervista, e grazie a tutti i magfarmiani, tranne ad una (she knows
who she is...)
ps: ehm, Tamb, dì la verità si vede troppo la
pubblicità ai miei libri in questa intervista?...
Direi di nò , ma i tuoi libri sono così interessanti che se anche calchi un pò la mano và bene , allora un grazie da me e da tutti i magfarmiani .
Mr. Tambourine
_________________________________________________________________________________________________________________
Joe Strummer: il ribelle filosofo
di Giovanna Mancini
(da Il sole 24 ore )

Non è detto che per apprezzare "Il futuro non è scritto", documentario
girato da Julien Temple e dedicato al leader dei Clash Joe Strummer (al
secolo John Graham Mellor, scomparso nel 2002), sia necessario essere un fan
della storica band inglese o del punk in generale. Perché, nonostante una
distribuzione penalizzante nelle sale italiane, i 119 minuti di questo film
composto come un mosaico a più voci scorrono fluidi tra registrazioni
dell'epoca, frammenti di video, animazioni realizzate su disegni dello
stesso Strummer, interviste ad amici e a personaggi dello spettacolo,
accompagnate da una splendida colonna sonora che, accanto alle musiche degli
stessi Clash, fa risuonare le note di Elvis Presley, Harry Belafonte, Bob
Dylan, i Ramones, Eddie Cochran e molti altri. Perché lo stesso Strummer
amava spaziare tra diversi generi musicali, dal rock al folk, dal reggae al
cumbia, fino al bhangra, e fu questa una delle caratteristiche che fecero
dei Clash una delle rock band più innovative degli anni Settanta-Ottanta.
Il documentario, girato dallo stesso autore che ha realizzato anche due
lungometraggi sui Sex Pistols, ruota attorno al concetto di falò, un
concetto fondamentale per lo stesso Strummer che, terminata l'esperienza con
i Clash (1976-1986), proprio dalla pratica dei raduni attorno ai falò e
della vita comunitaria tipica dei rave avrebbe saputo ritrovare
l'ispirazione necessaria per tornare da protagonista sulla scena musicale,
con i Mescaleros (1999-2002).
Julien Temple fa sedere accanto a un fuoco un gruppo di amici e conoscenti
di Strummer, dai compagni di scuola alla ex moglie, fino ad alcune star
hollywoodiane come Johnny Depp, Matt Dillon, Steve Buscemi e Martin
Scorsese, che raccontano il personaggio Joe Strummer per come lo hanno
conosciuto. In sottofondo, la voce dello stesso Joe, ripresa da stralci del
programma radiofonico "London calling" che condusse per la Bbc World Service
tra il 1998 e il 2002.
Il ritratto che ne emerge va oltre quello di una rock star che pure diede
tanto alla storia della musica: Joe Strummer, secondo le parole dello stesso
Temple, è tratteggiato come una sorta di grande filosofo contemporaneo,
attento e rispettoso della vita umana, profondamente radicato nelle sue idee
libertarie e rivoluzionarie, eppure ricco di contraddizioni e tensioni, come
l'epoca in cui visse.
I testi e la musica delle più celebri canzoni dei Clash (White riot, London
calling, Should I stay or should I go, Rock the Casbah, I fought the law)
sono i testimoni migliori di una società che tra gli anni Settanta e Ottanta
andava profondamente cambiando, tra rivolte giovanili, lotte per i diritti
civili e per i riconoscimenti delle minoranze. Joe Strummer, e con lui i
Clash, parlarono ai giovani della guerra, delle ingiustizie sociali, della
rivolta sandinista, del Vietnam e dell'Iraq. Bono Vox, uno dei tanti artisti
intervistati nel film, ammette che i ragazzi come lui non avevano idea di
dove fossero certi Paesi, o cosa vi accadesse, prima che la voce di Joe
Strummer glielo raccontasse.
Ma i Clash ebbero anche il grande merito di aprire il punk ai neri, sia
accogliendone le sonorità musicali, sia attraverso testi che parlavano anche
di loro. Perché questo fu Joe Strummer prima di tutto: un ribelle convinto
che la ribellione ha senso solo se serve a costruire un mondo migliore.
Prima hippy, poi punk, infine attratto dall'aspetto sociale dei rave, sempre
e comunque attento a ogni fenomeno sociale e musicale, Strummer cercò sempre
di dare un significato alla sua vita: "diventare adulti – spiega a una delle
figlie – significa imparare il rispetto verso il prossimo". Che, detto da
un'icona del punk che gridava alla "rivolta bianca", ha un valore enorme. Ma
la rivolta di Strummer non è mai distruttiva: è sempre finalizzata a una
lotta per la libertà e l'uguaglianza.
Ancora, il film di Temple è la storia, triste e insieme piena di speranza,
di un uomo tormentato che, spaventato e disgustato dal suo stesso successo,
stenta a trovare una nuova strada nella vita. Quando infine, dopo un periodo
passato a scrivere colonne sonore o recitare piccole parti nei film, torna
alla ribalta con i Mescaleros, il suo messaggio sembra addolcirsi ma in
realtà è sempre lo stesso: "ho una sola cosa da dire – ammette –
l'importante è essere vivi". Ciascuno di noi, è il credo di Joe Strummer,
può cambiare la sua esistenza e costruire davvero un mondo migliore, se solo
trova il coraggio di uscire dai binari lungo cui tutti, quotidianamente,
camminiamo. Perché il futuro, davvero, non è scritto.
"Il futuro non
è scritto – Joe Strummer"
Titolo originale: Joe Strummer: The future is unwritten.
Genere: documentario. Regia: Julien Temple. Fotografia: Ben Cole. Con: Bono
Vox, Steve Buscemi, Matt Dillon, Johnny Depp, John Cusak, Terry Chimes, jim
Jarmusch, Mick Jagger. Colore, 124 minuti. Produzione: Irlanda, Gran
Bretagna 2007. Distribuzione Ripley's Film.
Siti ufficiali:
www.joestrummerilfilm.it;
www.theclashonline.com.
| ______________________________________________________________________________________________________________________ |
I due film su Bob Marley entrano in conflitto
La vedova del compositore giamaicano sembra prediligere il progetto documentaristico di Scorsese, non concedendo i diritti per le canzoni al film prodotto dalla Weinstein
Articolo di Nicola Cupperi - Pubblicato mercoledì 26 marzo 2008

Ultimamente sono stati prodotti molti film su mostri sacri della scena musicale, da Johnny Cash a Ray Charles fino ad arrivare al più recentemente omaggiato Bob Dylan. Non sorprende, dunque, la volontà di omaggiare un grandissimo della musica mondiale come Bob Marley, approfittando anche, come tempi di distribuzione, del 65simo anniversario della sua nascita, che cadrà nel febbraio del 2010. Inoltre l’immensa figura di Bob Marley ha ispirato addirittura due progetti differenti, annunciati praticamente contemporaneamente. Si tratta di un biopic di fiction prodotto dai fratelli Weinstein - e ispirato ad un libro di memorie scritto dalla moglie di Marley, Rita, che ne è anche produttrice esecutiva - e di un documenario diretto nientemeno che da Martin Scorsese, il quale collaborerà direttamente con la famiglia del musicista scomparso nel 1980 e avrà libero accesso a documenti audio e video inediti che saranno inseriti nella pellicola.

Si prevede però che le celebrazioni per il 65esimo anniversario della nascita del musicista giamaicano saranno piuttosto movimentate, perchè nonostante Rita Marley sia tra i produttori esecutivi del progetto della Weinstein, si rifiuta di cedere i diritti sui brani di suo marito alla società di produzione sostenendo di avergli venduto solo i diritti per la trasposizione cinematografica del suo libro, e nient’altro. La famiglia Marley inoltre, non era a conoscenza del fatto che la Weinstein aveva programmato l’uscita del suo film per la fine del 2009, e questo sicuramente interferirebbe con il debutto nelle sale del film di Scorsese (che dovrebbere uscire agli inizi del 2010, proprio in occasione del grande anniversario), un progetto al quale loro tengono particolarmente: Al momento tutte le nostre energie e gli sforzi sono concentrati sul documentario ha detto Ziggy Marley, figlio di Bob Crediamo che questo progetto sia il modo migliore di raccontare la vita di mio padre dal suo punto di vista, ed altri film incentrati su di lui sarebbero vuoti, senza la sua musica a fare da supporto.
L’avvocato che rappresenta la famiglia Marley, Terri DiPalo, nega che la decisione di non cedere i diritti sui brani alla Weinstein sia una tattica per costringere la società di produzione ad acquistarli, magari ad un costo elevato, è più probabile invece che stiano cercando di far spostare l’uscita della biopic al 2015, come ha rivelato Chris Blackwell, presidente della casa discografica di Marley, la Blue Mountain Music. Blackwell sostiene di aver incontrato i dirigenti della Weinstein lo scorso 13 marzo, ma la questione non è stata ancora risolta.
Testo tratto dalla rivista online NonSoloCinema anno IV n. 12 - © 2008
_______________________________________________________________________________________________________________________
Le confessioni di Jacob Dylan
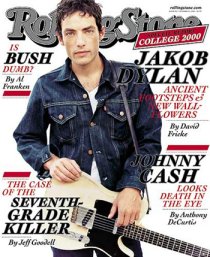
Nell’edizione dell’ottobre 2000 di “Rolling Stone”, Jacob Dylan fece la sua intervista più lunga. E la domanda inevitabile fu “Come sei cresciuto in casa Dylan e il peso di essere il figlio di Bob Dylan”.
<<Non ricordo la prima volta o quante volte ho visto “Don’t look back”. Per noi era come se fosse la fotografia più importante della nostra famiglia. E pensare che lui –Jacob non pronuncia mai il nome Bob o “mio padre” o “mio papà”. Ma è solo “lui” “suo”- aveva solo 24 anni al tempo, per cui era più giovane di me!>>
Jacob, con il suo gruppo “The Wallflowers”, ha già venduto più di 6 milioni di dischi ma, nonostante ciò, ammette di essere invidioso, pur riconoscendo che la scena musicale di allora era completamente differente: <<Lui è così grande che è nei libri di storia, nelle scuole, innumerevoli libri e biografie ma probabilmente una sola pagina menziona i nomi dei suoi figli.>>
Jacob tenne il suo cognome segreto per molti anni, preferendo cominciare dalla gavetta come un apprendista. Solo nel 1997 avevano fatto 275 spettacoli come “support group” ai “Counting Crows”. <<Facevamo cinque serate alla settimana e nei giorni di riposo cercavamo un locale per suonare la nostra musica.>>
Parlando della sua infanzia, Jacob ricorda: <<Non avevamo dischi d’oro sui muri in casa nostra ma quando andavo dai miei amici i loro genitori mi mostravano sempre suoi ritagli di giornale o cimeli.>>
Jacob nacque a New York nel dicembre 1969 e presto si trovò a vivere in New Mexico e Arizona prima di stabilirsi in California per molti anni per poi ritornare a New York. Quando i suoi genitori divorziarono nel 1977, passò del tempo con entrambi ma trovò più somiglianze con il carattere della madre Sara: <<Ha una personalità molto forte che l’ha aiutata a sopportare tutto quello che accadeva intorno alla famiglia in quegli anni. Quando iniziai ad ascoltare il suono inglese della “new wave”, cominciai ad interessarmi alla musica. Soprattutto “The Clash”, Elvis Costello e “The Buzzcocks” ed ero sempre felice quando lui prendeva un album e ne guardava la copertina.>>

Ma Jacob ammise di essersi fatto prendere dalla passione della musica durante il tour con Bob e Tom Petty nel 1986: <<Non ricordo nulla degli spettacoli del 1974 o di “The Rolling Thunder” del 1975 e ’76 ma mi ricordo bene “Europe 1984” e di come la gente reagiva intorno a lui. Persone che io ammiravo si scioglievano davanti a lui e questi erano i miei eroi! Erano completamente sopraffatti dal solo vederlo e parlargli. Allora cominciai a capire che le sue canzoni significavano tanto a tutte quelle persone.>>
Jacob racconta di quando suo padre entrò in ospedale a causa di una pericolosa infezione al cuore: <<La gente del mondo della musica era in uno stato di panico perché si rese conto che avrebbe potuto perderlo ed io ero così arrabbiato e pensai: “Vergognatevi! Voi pensate che persone come lui spuntino fuori continuamente. Invece dovreste essere orgogliosi di vivere nella sua stessa epoca”. La gente è così strana!>> (n.d.r. Io penso che tutti noi di Maggie’s Farm saremmo d’accordo, yeah? Dylan disse di quel periodo: “Pensai che avrei incontrato nuovamente Elvis!”)
( Dean Spencer news )
_________________________________________________________________________________________________________
Ricordando il più grande pesce d'aprile degli ultimi 30 anni............
PAUL McCARTNEY: VIVO O MORTO??
Una delle tesi è questa: nel novembre del 1966, dopo aver litigato con gli altri Beatles, Paul, uscito dagli studi di Abbey Road con la sua Aston Martin, avrebbe avuto un incidente e sarebbe rimasto decapitato. Gli altri Beatles lo sostituirono con un certo William Campbell (o Billy Shears, si dice di pelle nera), il quale subì una plastica facciale. Questo nuovo Paul sarebbe addirittura più bravo dell'originale spiegando così il nuovo stile nel suonare il basso e la bravura nel comporre canzoni. Lo stesso Paul (o chi abbia preso il suo posto) non ha smentito subito queste voci alimentando così una vera propria mania di ricercare messaggi nascosti nelle opere dei Beatles. Ancora oggi ci sono persone convinte che Paul sia morto.. ma viste le presunte tracce lasciate dai Beatles (di proposito o no) come dar loro torto?


E ancora: mettendo uno specchio nel mezzo della batteria si legge: "I ONE IX HE DIE", cioè: Undici (uno-uno), nove (IX, in romano), lui è morto. Il 9 novembre data della morte di Paul; e, guarda caso, la freccia tra “He” e “Die” punta proprio verso Mc Cartney.


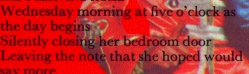
strofe dicono : “Ho letto le notizie oggi: Oh, Dio! Riguardavano l’uomo fortunato che aveva raggiunto la sua meta (gli inglesi dicono HE MADE THE GRADE come eufemismo per dire E` DECEDUTO) e nonostante le notizie fossero letteralmente tristi mi misi a ridere. Ho visto la foto, ha lasciato la sua anima in un’automobile (altro eufemismo: TO BLOW HIS OWN MIND significa anche PERDERE LA TESTA ...) non si era accorto che il semaforo era cambiato, una folla di persone stava lì attonita: conoscevano quella faccia. Nessuno voleva credere che fosse un Lord (Baronetto?...).”
Un altro riferimento alla morte di Paul è chiaro nella copertina di una loro raccolta, "A Collection of Beatles Oldies (but Goldies)"Un disegno stile anni 20 per una nuova raccolta di successi dei Beatles. Innocuo, ma solo in apparenza: si può infatti vedere un automobile che si dirige pericolosamente verso la testa del personaggio in primo piano...

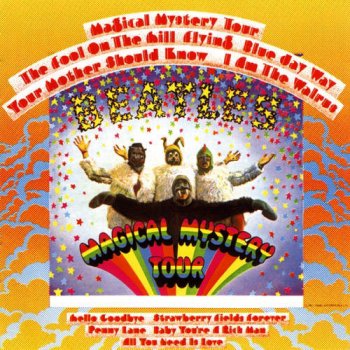





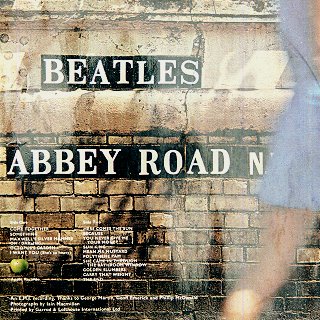


In questa foto Paul McCartney è l'unico a portare all'occhiello il fiore nero...

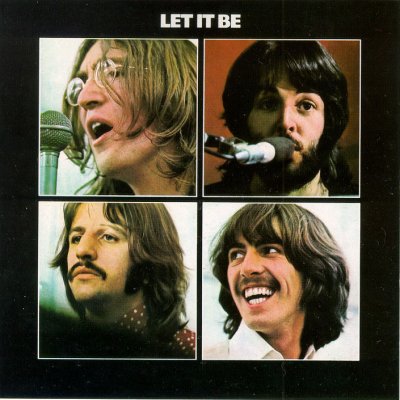
Volete divertirvi a comparare le foto del viso di Paul ? cliccate qui
TALKING BOB DYLAN BLUES - Parte 400 - La posta di Maggie's farm - clicca qui
_____________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
 |
|
Maharishi (che significa il grande veggente) aveva introdotto la sua tecnica negli Stati Uniti nel 1959, ma il movimento acquisì una notorietà internazionale dopo la visita che i Beatles fecero al suo ashram in India nel 1968.
Maharishi, annuncia il portavoce del Movimento, si è spento serenamente» nella sua casa, per cause naturali. Il suo nome è legato a quello del gruppo di Liverpool da quando i Beatles, con mogli e amici al seguito, si recarono in India per imparare i suoi insegnamenti. Gli esiti non furono felicissimi: Ringo Starr lasciò dopo una settimana, e lo stesso John Lennon non dovette essere del tutto convinto dei meriti del guru se «dedicò» al Maharishi la canzone «Sexy Sadie» (senza però citarlo per nome) né l’allusione ai «Guru con la Bentley» in un successivo brano dei Cream appare casuale.
Si era «ritirato a vita privata» solo pochi
giorni fa, alla fine di gennaio , dopo cinquant’anni di instancabile
proselitismo e di gestione in prima persona di un impero economico che
ha esteso i
suoi interessi dal settore immobiliare a quello dei medicinali e dei
cosmetici ayurvedici. «Il suo lavoro è stato fatto, e piuttosto che in
campo amministrativo d’ora in poi si concentrerà nel silenzio e
nell’approfondimento della conoscenza», aveva commentato Benjamin
Feldman, «ministro degli esteri» del’Paese globale della pace mondiale,
il movimento fondato dal guru, famoso anche per la sua lunga barba
bianca e per la pratica della posizione del loto.
______________________________________________________________________________________________________________________
Dylan in Italia per tre date ( da Rockol.it ) clicca qui
Dylan ad Aosta il 18 giugno clicca qui
___________________________________________________
Il mio parere sugli album di Dylan
Di Daniele Andronaco
Dopo Springsteen tocca a Bob Dylan. Con lui sono stato più sintetico altrimenti con tutta la roba che ha fatto non ne uscivo più. Mi sono limitato agli album di inediti, il che significa che ho escluso:
- "Good as I been to you" e "World gone wrong", rispettivamente del '92 e del '93, perché non contengono nessun brano originale;
- "The basement tapes", perché è una raccolta di pezzi registrati nello stesso periodo ma non è stato concepito dall'inizio come un album (ed è stato pubblicato dopo otto anni);
- le innumerevoli raccolte, greatest hits e compagnia, che, a parte "Biograph" e i bootleg, non sono molto utili;
- i live, anche se quello del '66 in Inghilterra e quello della Rolling Thunder Review del '75 sono assolutamente imperdibili.
-----
Bob Dylan (1962)
Sembra strano parlare di un album di Bob Dylan in cui solo due pezzi sono scritti da lui. Dylan è ancora un musicista folk a tutti gli effetti, uno che con una chitarra acustica e un’armonica intrattiene la gente nei locali suonando brani della tradizione popolare. Questo disco, com’era ovvio, passò praticamente inosservato e ancora adesso in pochi se lo filano, come se fosse più una prova generale che un album vero e proprio. In realtà Bob Dylan è anche questo, ed è stato proprio venire dal folk il principale vantaggio rispetto ai suoi colleghi degli anni ’60. A colpire i discografici (sempre John Hammond) era stato il suo personaggio: aveva tutto l’entusiasmo di chi, arrivato dalla provincia, ha scoperto il fermento artistico del Greenwich Village di quei tempi, e l’originalità di chi ora si rifà apertamente a Woody Guthrie ma è pur sempre cresciuto con Elvis. Qui ci regala alcune interpretazioni niente male, in cui cambia con agilità stili e tecniche, spesso e volentieri con incursioni nel blues. Ci sono anche le (belle) versioni di In my time of dying, che fa un certo effetto per chi ha nelle orecchie quella dei Led Zeppelin, e House of the rising sun, prima che gli Animals la rendessero famosa.
The freewheelin’ Bob Dylan (1963)
Blowin’ in the wind spalanca le porte del successo mondiale a questo ragazzo ebreo cresciuto in un paese lontano dal mondo nel Minnesota. Poche parole semplici semplici ma che hanno la fortuna di essere quelle che in molti volevano sentirsi dire in quel periodo. E il disco non è solo questo: per gli amanti della poesia beat ci sono le visioni apocalittiche di A hard rain’s a-gonna fall e per i pacifisti più incazzati c’è Masters of war. In maniera del tutto inaspettata, la musica scopre di avere trovato un grande autore. I seguaci del folk credono di aver trovato l’erede di Woody Guthrie.
The times they are a-changin’ (1964)
Per chi lo considera un “cantautore d’attualità” Dylan rincara persino la dose. “The times they are a-changin’” è da sempre ritenuto il suo album più politico, ma in realtà lui di politica non ci capisce nulla. È solo un ragazzo ingenuo, naif, per alcuni aspetti immaturo, che riversa nelle sue canzoni la simpatia e il sincero entusiasmo che prova per certe cause. Quel che è certo è che qui lo fa quasi dall’inizio alla fine, spesso con un’intelligenza di cui in seguito si sentirà la mancanza. La title-track ha avuto meno successo di “Blowin’ in the wind” proprio perché meno facile, e tra gli altri brani spiccano When the ship comes in e With God on our side, un altro bellissimo attacco al militarismo.
Another side of Bob Dylan (1964)
Il titolo oltremodo didascalico ovviamente fu imposto dal produttore. In effetti non è del tutto chiaro se si tratti di un altro lato di Bob Dylan o semplicemente della sua maturazione. È il suo ultimo disco senza band ma questo non basta per definirlo folk. Dovrebbe essere una specie di parentesi intimistica ma in realtà è il primo (e più involuto) episodio di una lunga serie. E c’è un pezzo, Chimes of freedom, che parla ancora delle tematiche dell’album precedente, ma per la prima volta in modo totalmente visionario, quasi astratto. C’è It ain’t me, babe, che suona come il suo primo esplicito rifiuto di qualsiasi etichetta. E c’è My back pages, in cui Dylan ripudia apertamente la schiavitù delle ideologie: “ero molto più vecchio allora, adesso sono più giovane”.
Bringing it all back home (1965)
È famoso soprattutto per essere stato il primo disco di Bob Dylan a fare un uso regolare di una band (tutto il lato A), ma è un altro album di transizione. Nel lato elettrico spiccano Subterranean homesick blues, col suo fiume di rime simile addirittura a un rap, Maggie’s farm e Love minus zero / No limit. Nel lato B Dylan continua a sperimentare una scrittura più visionaria e asseconda il suo furore poetico tanto da faticare a volte a seguire lo schema delle rime; ne vengono fuori Gates of Eden e Mr. Tambourine Man, incantevole e allucinata celebrazione della fantasia, ma anche l’arrabbiata It’s alright, ma (I’m only bleeding) e la delicata It’s all over now, baby blue.
Highway 61 revisited (1965)
Semplicemente un capolavoro. Dylan prende da Elvis, da Rimbaud, dalla Bibbia e dai poeti beat, scompone, rimischia, taglia e cuce esperienze culturali diverse, prende un chitarrista blues per dirgli che non vuole “roba alla B.B. King”, trascende le definizioni di genere perché domina e gestisce a suo piacimento musiche e testi, inseparabili e fusi in una sintesi perfetta. Pochi mesi dopo un disco “normale” come “Bringing it all back home” e anni prima dell’esplosione della psichedelia, quando i Beatles erano un gruppo pop e i Rolling Stones facevano cover, lui prende il comando della rivoluzione e inventa un nuovo modo di concepire la musica popolare. Scrive un pezzo liberatorio come Like a rolling stone, esaltato da un’esecuzione impareggiabile, in Desolation Row mette tutta la cultura occidentale in un Vicolo della Desolazione fatto solo di caos, in Ballad of a thin man si prende gioco di chi crede di poterci capire qualcosa. I puristi del folk gli daranno del giuda, e invece è soltanto un artista.
Blonde on blonde (1966)
Come succede spesso dopo un capolavoro, Dylan esagera, pubblicando un doppio LP di ben settantatré minuti in cui porta all’estremo la carica visionaria del disco precedente (il lungo flusso di coscienza di Visions of Johanna ne è l’esempio più lampante). Si parla d’amore, ma in testi fatti di immagini, che sfuggono allo schema tradizionale, come I want you e Absolutely sweet Marie fino a Sad-eyed lady of the lowlands, semplicemente la più bella canzone d’amore mai scritta. Anche il suono è curato in modo eccessivo, molto più pop e molto più morbido (a questo probabilmente allude il “biondo” del titolo). Come “Highway 61”, “Blonde on blonde” è un collage di colori e citazioni, non un semplice disco ma un’opera d’arte.
John Wesley Harding (1967)
Bob Dylan è già stanco di essere una rockstar e un incidente con la moto gli dà l’occasione di allontanarsi per un po’ dalle scene. Per qualche anno pubblicherà dei dischi particolari, di difficile collocazione, e non andrà più in tour fino al ’74. Se col folk aveva rotto, col rock genere Woodstock non vuole averci niente a che fare. Qui, con la chitarra acustica e accompagnato solo da basso e batteria, canta testi estremamente ermetici, pieni di riferimenti alla Bibbia, sulla cui interpretazione si sono fatte innumerevoli ipotesi. In mezzo c’è anche All along the watchtower, che Jimi Hendrix trasformerà in un capolavoro.
Nashville skyline (1969)
L’album è famoso soprattutto perché nell’anno dell’apice della musica impegnata Dylan se ne uscì col suo disco più leggero, con testi mostruosamente banali e musiche in tutto e per tutto country. Ma non è questo il problema più grave, né il fatto che “Nashville skyline” neanche come disco country sarebbe eccezionale, né il timbro di voce che Dylan ha improvvisamente tirato fuori, ancora più assurdo della faccia con cui sorride non si sa bene per cosa sulla copertina. Il problema più grave è che “Nashville skyline” manca di qualsiasi originalità, come se per la prima volta Bob Dylan si sia abbandonato agli stereotipi di un genere musicale. Lay, lady, lay ebbe qualche successo come singolo, e in effetti è l’unico brano a conservare un po’ del mestiere dei vecchi tempi.
Self portrait (1970)
Dylan è uno che prepara con cura anche le sue schifezze, per cui quando dice che con “Self portrait” volle fare apposta un album brutto in parte gli si può credere. Probabilmente la verità è che in un periodo in cui il pubblico pretendeva da lui qualcosa di più profondo, lui si divertiva a lasciarsi andare con un disco decisamente bizzarro e pieno di cover inutili. Quando parte All the tired horses sembra quasi una bella trovata iniziare con un’introduzione cantata da un coro di voci femminili, ma due tracce più avanti l’insopportabile interpretazione di I forgot more than you’ll ever know affossa ogni speranza; subito dopo Days of 49 (il pezzo migliore del disco) riaccende l’attenzione per un po’, ma alla fine di un lungo ascolto (se “Nashville skyline” durava appena mezzora qua siamo oltre i settanta minuti) “Self portrait” emerge per quello che è, un album impossibile da prendere sul serio, in cui anche quando arriva una versione live bruttarella di Like a rolling stone si può non gridare al sacrilegio e non resta che consolarsi con qualche pezzo divertente come Belle Isle e Gotta travel on.
New morning (1970)
A soli quattro mesi da “Self portrait”, Dylan dovrebbe tornare a fare un disco normale, ma i risultati continuano a deludere, e stavolta la scusa di averlo fatto apposta non regge per cui si può parlare tranquillamente di calo di ispirazione. Soprattutto non c’è traccia della bellezza e dell’intelligenza dei testi dei giorni migliori. Day of the locusts, New morning e The man in me sono fra i pochi guizzi di un album troppo nella media per essere di Bob Dylan.
Planet waves (1974)
Un album minore dall’inizio alla fine, purtroppo l’ennesimo da molti anni. Neanche Forever young, presente in due versioni (meglio quella lenta), può cancellare questa sensazione. Dylan canta male e questo nuoce anche a un bel testo come Dirge. Neanche la Band (quella con la b maiuscola, Robbie Robertson e compagni), per la prima ed unica volta riunita anche in studio, è ai livelli di un tempo, e il live “Before the flood”, registrato quello stesso anno, lo conferma, se paragonato al tour del ’66. A sorpresa, la cosa migliore che Bob ha combinato negli ultimi almeno sette anni è la colonna sonora di “Pat Garrett & Billy the Kid”, uscita nel ’73.
Blood on the tracks (1975)
Critica e pubblico lo ritengono unanimi un capolavoro, per cui qui la cosa è personale. Dirò subito che è un bel disco, il primo veramente ispirato da quasi dieci anni a questa parte, ma ascoltandolo ho la netta impressione che Dylan stia ancora cercando di recuperare quello che aveva perso, e che sia lui il primo a saperlo. Tangled up in blue è una bella canzone ma impallidisce di fronte a quelle degli anni ’60, e Idiot wind farebbe una figura migliore se non costringesse al paragone con “Like a rolling stone”. Oltretutto, le musiche non sono certo entusiasmanti: appena qualche chitarra acustica e un suono troppo pulito per quello che ci si aspetta da Dylan; una canzone come Shelter from the storm suonerà molto meglio dal vivo in versione elettrica.
Desire (1976)
Tutti conoscono Hurricane, ritorno alla canzone di protesta dopo dodici anni ma anche frutto di un nuovo gusto per la narrazione in modo fin troppo epico di storie vere, lo stesso che sta dietro a Joey, biografia a dir poco romanzata del gangster Joey Gallo, trasformato da Dylan in un novello Jesse James. Ma a fare di “Desire” uno dei suoi album migliori è la combinazione tra le insolite atmosfere gitane e i testi al limite del surreale e resi molto teatrali dalla collaborazione col commediografo Jacques Levy. Finalmente con “Desire” (e col bellissimo tour di quel periodo, la Rolling Thunder Review) Dylan riesce ad elaborare la nostalgia per i tempi andati per raggiungere una seconda giovinezza. E per pezzi come Isis e Black Diamond Bay si può tornare ad usare l’aggettivo “geniale”.
Street legal (1978)
Sono passati due anni e mezzo da “Desire” ma sembrano molti di più. “Street legal” è quasi più un album degli anni ’80, col suo suono smaccatamente pop rock, la voce sguaiata, i cori femminili in sottofondo, le canzoni che per la prima volta suonano esattamente come suoneranno dal vivo e, caso invece unico, una band enorme con tanto di sax. Dylan è in un momento particolare, ha appena divorziato dalla prima moglie, e questo si riflette nelle canzoni, ancora più ermetiche del solito, arrabbiate, confuse, disilluse. No time to think (bellissimo testo e unico vero sussulto, insieme a Señor) è il nuovo motto: ogni ideologia è un’illusione, ogni razionalizzazione è una falsa coscienza; nella vita non c’è tempo per pensare.
Slow train coming (1979)
Se non capite l’inglese vi sembrerà un ottimo album, sempre che non odiate i Dire Straits. Padrone della scena è infatti Mark Knopfler, che fa oggettivamente un lavoro eccellente e si porta dietro il batterista Pick Withers. Purtroppo Dylan è entrato nella parte più ridicola della sua carriera. Improvvisamente si è convertito al cristianesimo e trasformato in un insopportabile predicatore, si definisce un profeta, i suoi concerti sono dei lunghi sermoni in cui predice la venuta di Cristo e la fine del mondo. Gotta serve somebody e Precious angel preparano la strada, ma poi arriva I believe in You, in cui Bob si dice emarginato a causa della sua fede neanche vivesse a Roma prima di Costantino. L’uomo del caos e dell’anti-ideologismo ha trovato la risposta. E a chi ancora pensa che non esista dedica When you gonna wake up?.
Saved (1980)
Stavolta non c’è nemmeno Mark Knopfler a salvare la baracca. “Saved” è l’album più monocorde del periodo cristiano, incline al gospel anche nelle musiche e coi testi che non danno un attimo di tregua. Nei momenti peggiori è un’accozzaglia di luoghi comuni, nei momenti migliori ascoltarlo non è molto diverso da leggere la Bibbia, se non fosse che quella era l’originale e questo è una copia.
Shot of love (1981)
Finalmente Bob Dylan allenta un po’ la presa: in questo disco torna ad esserci qualche canzone normale e anche quelle religiose sono meno banali e asfissianti. C’è persino un brano dedicato a Lenny Bruce, come a dire “non tutti gli atei fanno schifo”. Qua e là ci sono pezzi veramente piacevoli, come The groom’s still waiting at the altar e il reggae di Dead man, dead man. E quello più estremista è Every grain of sand, un Dylan melodico come non ci si aspetterebbe (e forse neanche si vorrebbe) ma sicuramente in forma.
Infidels (1983)
La band è di all star (Mark Knopfler e l’ex Rolling Stone Mick Taylor alle chitarre e la coppia reggae Robbie & Sly alla sezione ritmica), ma si sente fino a un certo punto. Accantonati i toni fideistici, Dylan è ancora arrabbiato, politico come non lo era dai tempi di “The times they are a-changin’”, ma per quanto da ventenne era idealista da quarantenne è sbrodolone. In Neighborhood bully difende Israele, in Man of peace ci mette in guardia dai Satana che si presentano come uomini di pace, in Union sundown se la prende col capitalismo e con la globalizzazione, in License to kill arriva a dire che “solo perché domina il mondo l’uomo pensa di poterne fare quello che vuole”; persino in una canzone come Sweetheart like you il refrain è “cosa ci fa una dolcezza come te in questa fogna?”. Il capolavoro del disco è Jokerman, un’allegoria dei “manipulator of crowds”, che siano Dio, il presidente o un cantante.
Empire burlesque (1985)
Sembra che negli anni ’80 non si potesse fare a meno di riempire i dischi di sintetizzatori, e neanche Dylan fa eccezione. Bob non era mai stato (e non sarà mai più) tanto ammiccante verso le mode musicali e tanto rockstar. “Empire burlesque” è anche il primo album della sua carriera registrato senza una band fissa e senza un lavoro costante in studio, con partecipazioni estemporanee tra cui Ron Wood dei Rolling Stones e il ritorno di un collaboratore storico come Al Kooper. Nei limiti del possibile qualcosa di buono c’è (Clean-cut kid, che scherza ma mica tanto sul reclutamento dei giovani nell’esercito), ma ci vuole forza di volontà per ascoltare When the night comes falling from the sky fino alla fine. E, quando, insperato, Dylan torna voce, chitarra e armonica per la gemma Dark eyes, viene tanta nostalgia.
Knocked out loaded (1986)
Come il successivo “Down in the groove”, è anche difficile chiamarlo un disco di inediti, pieno com’è di cover e brani registrati senza impegno in momenti e con musicisti diversi. Per sentire qualcosa che sia sopportabile bisogna aspettare sei tracce, quando arriva Brownsville girl, undici minuti che ricordano i brani epici di una volta, frutto della collaborazione col commediografo Sam Shepard, seguita da Got my mind made up e Under your spell. Sarà un caso ma sono altre due collaborazioni: la prima scritta con Tom Petty e suonata con gli Heartbreakers al completo, la seconda con Dave Stewart degli Eurythmics.
Down in the groove (1988)
Stessa storia del disco precedente, ma forse nel complesso questo è appena appena più riuscito. Il fatto è che ormai Dylan sembra non avere più niente da dire. Si continuano a ripescare cose già registrate (c’è persino un’outtake di “Infidels”, Death is not the end) e continua la carrellata di ospiti: Ron Wood non nega una comparsata ormai da qualche anno e stavolta tocca anche a Paul Simonon dei Clash e ad Eric Clapton. Nell’inconsistenza generale le cose più decenti sono Let’s stick together e i due divertissement scritti con Robert Hunter, Ugliest girl in the world e Silvio.
Oh mercy (1989)
Dylan si affida a Daniel Lanois e se “Oh mercy” è un ottimo album come lo aspettavamo da più di un decennio è merito del produttore canadese ancora di più che della scrittura. Lanois costruisce delle atmosfere cupe e degli arrangiamenti scarni, senza gli orpelli degli anni ’80, restituendo alle canzoni lo spessore che per troppo tempo era mancato. Man in the long black coat è il punto più alto della collaborazione, ma anche la ballata Most of the time, il rock blues di Everything is broken e la conclusiva Shooting star dimostrano che Dylan è tornato.
Under the red sky (1990)
Via la produzione di Daniel Lanois, tornano gli ospiti di lusso: tra gli altri, i fratelli Vaughan, George Harrison, Slash ed Elton John. Della scrittura di “Oh mercy” Dylan sviluppa il lato più leggero, a volte umoristico, per un disco di semplice rock blues, sicuramente prescindibile ma almeno senza pretese. Tra gli episodi (relativamente) più riusciti, la title-track, God knows e Handy Dandy, una specie di cugina scema di “Like a rolling stone”.
Time out of mind (1997)
È il primo album del Dylan anziano, sempre più isolato dalle grandi ribalte nell’esilio del suo tour perenne. Alla produzione torna Daniel Lanois, che coglie i toni crepuscolari di molti testi e cerca di sottolinearli con atmosfere ancora più cupe che in “Oh mercy”. Ne esce il disco più solenne di Bob, anche oltre le sue intenzioni. A trarne giovamento sono pezzi come Standing in the doorway, Cold irons bound e soprattutto Not dark yet; più penalizzati dagli arrangiamenti sommessi i blues leggeri, come Dirt road blues e Million miles.
“Love and theft” (2001)
Uno dei suoi dischi migliori, che solo un Dylan maturo poteva orchestrare. È un omaggio alla musica tradizionale americana da parte di uno dei suoi maggiori conoscitori nonché migliori esponenti, un viaggio nelle origini del rock’n’roll, nel rockabilly, nel blues, nel country, in cui il vecchio si mischia col nuovo, il passato col futuro. I testi sono immagini di un’America che non c’è più, campestre e rustica, con sguardi ad hoc alla modernità e sempre più citazioni. Mississippi e High water sono i pezzi migliori di un disco che ha il punto forte nell’insieme. Alla fine dell’ascolto il primo paragone che viene in mente è con “Highway 61”, ed è solo in parte un’eresia. Chi l’avrebbe mai detto? A sessant’anni Dylan è ancora di un altro pianeta.
Modern times (2006)
Dylan ormai ha troppo mestiere per fare un album brutto; soprattutto non ne ha l’intenzione, neanche quando ricorrerebbe il presupposto di tutti i suoi precedenti fallimenti: la totale disaffezione per l’ambiente musicale che lo circonda. Bob è tornato ad essere un cantante folk, la sua musica è tutta un furto, come aveva già detto in “Love and theft”. Non c’è una canzone in “Modern times” che si possa dire una composizione originale, sono tutti riadattamenti, ricomposizioni quando non rifacimenti, le citazioni si moltiplicano (saccheggiato il poeta Henry Timrod), i testi e il linguaggio sono presi in prestito dalla tradizione. Anche quando, in Workingman’s blues #2, dice che “il potere d’acquisto del proletariato è diminuito” Bob non riesce a sembrare attuale. Al di là dei difetti d’esecuzione, cioè la band che sta troppo attenta a non strafare e un Dylan sempre più aspirante crooner (col risultato, va detto, di cantare abbastanza bene!), che rendono melodiche e pulite le canzoni lente quanto noiose quelle veloci, di “Love and theft” manca la ricerca. Questo è il disco di un vecchio che non riesce ad abituarsi all’ignavia dei Tempi Moderni. Se “Love and theft” voleva essere un viaggio nel passato della musica americana, “Modern times” vuole essere il passato.
Ci sono vari motivi per cui la gente può apprezzare Bob Dylan: la protesta politica, l’idealismo, la tensione religiosa. C’è Bob Dylan folk e rock&roll, poetico e volgare, romantico e maschilista, marito e puttaniere, umorista e distaccato, milionario e campagnolo, sincero e “personaggio”. Semplicemente c’è Bob Dylan. Un artista sempre fedele a se stesso, chiunque sia “se stesso”. Un artista che da quasi cinquant’anni confeziona album sempre nuovi e continua ad andare dritto per la sua strada. In attesa di dipingere il suo capolavoro.
________________________________________________________________
Bob Dylan's Screen test clicca qui
__________________________________________
Uno nessuno cento Dylan
Incontro conTodd Haines per parlare del suo ultimo film che stravolge e reinventa il genere della biografia musicale
Uscito stranamente negli Stati Uniti più di un mese dopo la release italiana, Io non sono qui è il film chiacchierato, discusso, maledetto e celebrato di Todd Haynes, in cui diversi attori interpretano vari aspetti di Bob Dylan, senza che nessuno di loro incarni alla lettera Dylan nella sua interezza. Pieno zeppo di musica - le canzoni originali cantate da lui nella colonna sonora, ma anche reinterpretate dagli attori e ancora performate ma con voci nuove, come quella di John Doe (un tuffo travolgente nelle profondità del gospel dylaniano dell'80, Pressing On), Jim James e dei Calexico (Goin' to Acapulco), Stephen Malkmus (Ballad of a Thin Man), Tom Verlaine (Cold Iris Bound) - il film non sacrifica però mai la propria storia. Le dichiarazioni che seguono sono prese da un incontro col pubblico che Todd Haynes ha tenuto il 1 settembre 2007 al Telluride Film Festival per parlare del suo film. Il più bello del 2007 per noi di Rolling Stone.
Che cosa ti ha convinto a scegliere un'attrice per il ruolo principale?
«Era scritto e deciso fin dall'inizio che sarebbe stata un'attrice a interpretare Jude, ancora prima che scegliessi Cate Blanchett. Era esattamente quel momento della vita di Dylan. Ciò che era folle nel look dylaniano del 1966 era quel corpo emaciato, una testa enorme di capelli, le mani sempre in agitazione e quella specie di figura marionettistica che ovviamente stava sperimentando le droghe e vivendo al limite. Dopo l'incidente in moto, non ci furono mai più mani gesticolanti, né la massa di capelli e nemmeno quel corpo minuto e magro. Quel Dylan se n'era andato per sempre. E quella è un'immagine così famosa di Dylan. Ho cercato di infonderle di nuovo lo choc culturale che si deve essere provato nel vederla nel 1965, 1966. E così ho pensato che un'attrice avrebbe potuto essere interessante, perché in quell'immagine c'era una sorta di androginia. Non un'androginia alla Bowie, ma piuttosto alla Patti Smith».
Uno dei momenti più belli del film arriva dopo una scena in cui il Dylan interpretato da Cate Blanchett ha raggiunto un punto di crisi totale. Vomita e collassa a un party in una galleria in stile Warhol; viene spinto dentro una limousine circondata da fan che continuano a battere sui finestrini. L'auto parte di colpo, Jude guarda fuori dal finestrino, mentre una donna lo fissa negli occhi e si dà fuoco alla testa. Sembra che dica «è tutto finito». Da dove viene quest'immagine?
«Non riesco a ricordarmelo esattamente. Credo che sia qualcosa che ho letto e che è realmente accaduto, su Dylan esiste una marea di storie, aneddoti, stranezze, tra cui quella di un cameriere che gli diede una coltellata. Ovviamente, tutto quello che ha fatto è avvenuto due anni prima di quello che stava per accadere nella consapevolezza di massa, e quindi nel 1966».
Quant'è cambiata la tua visione dal momento in cui hai scritto la sceneggiatura al film finito?
«È rimasta molto vicina all'idea originaria, che ha iniziato a emergere nel 2000. C'era un personaggio diverso, Charlie, che avrebbe potuto essere il protagonista di una delle storie raccontate da Woody. Un'immaginazione da un colpo e via, da cinema muto, chapliniano, un performer di numeri di magia ed equilibrismo, mediatore poetico tra i Beat e la gente del villaggio. Un personaggio circense, ma circondato da un senso di stravaganza. Mi piaceva l'idea di sette personaggi, ma diventavano un po' troppi, così Charlie è confluito in Woody, e qualcosa è stato preso in prestito anche da Billy. C'è così tanto materiale affascinante e intenso, quando ti immergi nell'universo dylaniano. È tutta una questione di mantenere ed escludere, e cercare di ottenere il meglio da ogni aspetto».
In che modo Io non sono qui allarga l'idea di "queerness" esplorata nei tuoi film precedenti?
«Adoro la posizione di Dylan del 1966 nei confronti della queerness. Ne parla molto nel libro No Direction Home di Robert Shelton. La gente pensa a Dylan come a un'icona übersessuale, e in molti sensi lo è. Ma nella NY degli anni 60 la scena Warhol era molto queer, e la scena Dylan molto meno. Credo che Dylan si rese conto che era una specie di indice di coolness. In effetti, il fatto che le donne con cui usciva si aspettassero qualcosa dopo una notte di sesso, era visto come una cosa all'antica e convenzionale. Mentre la queerness di Allen Ginsberg e della gente da cui era circondato, quella era cool. Quindi Dylan era solito dire che aveva fatto marchette appena arrivato a NY, nel 1961, e che così fece i primi soldi. Non lo ripeté mai più, dopo, lo affermò solo nel 1966. E poi c'è quella lunga citazione che dice: "Non capisco questa cosa, donne e uomini" - il discorso che nel film lui pronuncia sopra la scalinata viene direttamente da lì - "l'amore e il sesso ti incasinano sul serio, e non so perché. Non si tratta di uomini e donne, e neanche del fatto che le donne sono ciò che gli uomini desiderano. Un uomo può amare un uomo; una donna, un'altra donna, e una donna può amare un uomo". Qui cerca davvero di essere al di sopra delle categorie classiche di quel tempo».
In che modo la musica ti ha ispirato mentre scrivevi il film?
«La musica è stata tutto. Ho realizzato delle ossessive raccolte di canzoni basate su ogni personaggio. E sapevo che avrei voluto le registrazioni di Dylan nel film, era essenziale avere la sua voce come elemento vincolante di questa struttura potenzialmente caotica; quella voce che ci accompagna, canzoni che conosciamo e che associamo alla nostra storia personale. Ma sapevo anche che ogni volta che un attore avesse messo in scena una delle sue performance cantate, si sarebbe dovuto trattare di una nuova versione apposta per il film. Nessuno avrebbe fatto il playback sulla voce di Dylan. Quindi si offriva un'altra opportunità: prendere artisti tradizionali dell'era di Dylan, mescolarli con altri più recenti e creare una zona in cui la musica continua a vivere e a essere reinterpretata in un modo in cui, ovviamente, la musica di Dylan è sempre stata, da quando l'ha scritta. I'm Not There è in effetti l'unica registrazione di oggi di Dylan della nostra colonna sonora».
E questo è un vero colpaccio. I'm Not There è stata registrata solo una volta; non è mai stata scritta fino in fondo. Metà del tempo, Dylan farfuglia qualcosa per andare da un verso accennato a un coro scritto a metà. Forse perché è così aperta, per il suo essere non finita ha sempre colpito la gente come la più magica delle sue composizioni. E non è mai stata ufficialmente distribuita.
«Il pezzo è nella colonna sonora, così come una cover che i Sonic Youth hanno realizzato per il film e che appare nei titoli di coda. Dal momento che è una canzone non finita, quasi mai nata, per chiunque ne faccia una cover significa dover fare ciò che la musica folk ha sempre dimostrato, cioè ricreare, avere una nuova prospettiva. Riempire quelle sillabe indecifrabili con qualcosa che sia comprensibile. Thurston Moore la fa sua, ma continua questo processo di musica "di seconda mano"».
Come hai iniziato a interessarti a Dylan?
«Al liceo mi sono innamorato della sua musica e della sua voce. Blonde on Blonde soprattutto. Ricordo vagamente l'uscita di Desire, mentre mi ricordo bene di Street Legal e Slow Train Coming. La prima volta che l'ho visto in concerto è stata nel tour del 1979 a Los Angeles. Quindi per circa vent'anni ho viaggiato su strade diverse. E alla fine dei 30, dopo aver vissuto a New York per circa 15 anni, mi sono ritrovato all'improvviso di nuovo affamato di Dylan. Ora realizzo che c'era un senso in questo, come di un bisogno di un cambiamento schietto nella mia vita. Mi sono ricordato di quanto quella voce avesse registrato: il fascino del futuro, le possibilità che associavo all'adolescenza. A quel punto della mia vita avevo bisogno di un po' di quel succo vitale. Mi stavo organizzando per un viaggio in macchina per il paese, diretto a Portland. Lasciavo la città per scrivere un film che poi sarebbe diventato Lontano dal paradiso. È stata forse l'ultima volta in cui ho fatto una raccolta di nastri e ho messo in ordine la maggior parte dei dischi di Dylan che possedevo. Non vedevo l'ora di guidare da solo con quelle cassette. Ma in Kansas ho comprato The Anthology of American Folk Music e da allora ho continuato a scavare sempre più. Mi sono procurato una raccolta di tutte le registrazioni di Basement Tapes. Mi sono comprato le Bootleg Series, i primi tre dischi. Sono rimasto sorpreso da quell'antologia, da She's Your Lover Now, Blind Willie McTell. Ho anche scoperto Eat the Document, al Movie Madness di Portland, e mi ha sconvolto».
Il film che Dylan realizzò sul suo tour del 1966...
«Che approccio folle, irriverente, anticonvenzionale per un documentario rock di allora! Avrei poi copiato alcune delle strutture di quel film. C'è un momento in cui canta Tell Me, Momma e all'improvviso viene interrotto, e c'è una specie di discussione. Tutto realizzato con tagli di montaggio. È una raffinatissima, semplice serie di tagli. Non c'è un senso di continuità naturale, o di assistere a una singola performance. Quando vedi il Dylan di allora, come in alcune parti di No Direction Home, le performance sono fortemente drammatiche, esperienze vissute. Ma Eat the Document sembra guidato da amfetamine o da una sorta di rabbia, quasi un rifiuto di essere felici. E poi trovare le raccolte di tutte le interviste tra il 1965 e il 1966, molto drammatiche, come trascrizioni o arte performativa: era come se stessero urlando per essere rappresentate ancora, volevo sentirle suonare a volume altissimo, dar loro nuova vita, e ciò ha innescato una specie di urgenza creativa. Con tutto questo in testa, sono arrivate le idee per il film».
( Dean Spencer news )
____________________________________________________________________________________________________________________
Film : Factory Girl
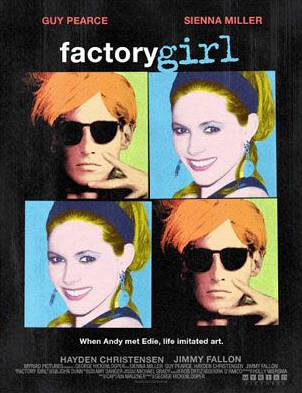
Gli anni ’60 sembrano essere sempre una gran fonte di ispirazione per il grande schermo. Sono usciti ieri nelle sale italiane due film che li celebrano: Across the Universe, splendido musical costruito seguendo l’ispirazione artistica dei Beatles, e Factory Girl, sulla vita di Edie Sedgwick, una fragile ragazza risucchiata e distrutta in breve tempo da Andy Warhol, il grande artista trasgressivo celebrato in questi giorni a Roma con una grande mostra.
Scritto e sceneggiato da Captan Mauzer che è anche il co-produttore, il film, girato in parte in stile documentaristico(pellicola sgranata finto d’epoca e interviste, ma anche documenti video e spezzoni originali dei film di Warhol), segue la tragica vicenda di Edie, una fragile e ricchissima ereditiera con velleità artistiche, che irrompe nella New York fine anni ’60 dove domina il genio sregolato di Andy e dei suoi comprimari, che fanno di una fabbrica abbandonata di birra, il nuovo tempio della cultura underground.
Edie diventa in breve la “diva” del cinema sperimentale di Warhol, ma continua ad essere ossessionata dai fantasmi familiari . La sua è un'antichissima e ricchissima famiglia che discende direttamente dai Padri Costituenti ma, dietro la facciata rigida e perbenista dei genitori (“gente di plastica” per dirla con Frank Zappa), si nasconde l’orrore: suicidi, incesti, ricoveri coatti in cliniche psichiatriche. Troppo fragile per evitare le facili lusinghe della droga, Edie ne resta imprigionata fino al degrado totale. Andy la butta via e Edie morirà d' overdose l’anno dopo.
Il ritmo del film è irregolare, alternando momenti di grande intensità (il gelido pranzo di presentazione familiare di Edie e Andy ) a fasi più stanche; ci sono tentativi di esplorare più in profondità il mondo di Warhol (dialogo con il prete nel confessionale, il rapporto intenso con la madre), ma il ritratto che ne emerge in complesso è superficiale e approssimativo.
Guy Pearce è un credibile Andy Warhol e ne rappresenta, con intensità e bravura, le debolezze e contraddizioni di uomo e di artista , Sienna Miller interpreta con la necessaria carnalità la Factory Girl; Hayden Cristensen è il Musicista che ha una breve storia d’amore con Edie e cerca di sottrarla alla droga. Facilmente identificabile in Bob Dylan, questa faccenda ha fatto inferocire il cantante che ha minacciato querele e sequestri. Anche Lou Reed , lanciato da Warhol con i Velvet Underground, si è arrabbiato molto e ha rilasciato dichiarazioni di fuoco contro il film.
Forse le polemiche aiuteranno per il successo della pellicola, ma
non hanno giovato alla colonna sonora che, probabilmente a causa di veti
vari, risulta debole, priva di tanti capolavori di quegli anni d’oro del
rock.
A quando un film sulla solista dei Velvet, Christa Paffgen, in arte Nico,
altra grande e tragica sacerdotessa della Factory di Warhol?
___________________________________________________________________________________________________________________
Video : Alessandro Carrera su Bob Dylan clicca qui
____________________________________________________________________
DUETS WITH BOB
Elenco dei dischi ufficiali di altri artisti dove Bob appare con un ruolo primario clicca qui
______________________________________________________________________________________________
LA CONTESSINA RIBELLE
Canzone preferita? Hurricane, di Bob Dylan clicca qui
______________________________________________________________________________________________
Dylan backing musician
elenco degli LP ufficiali di altri artisti dove Dylan appare come backing-musician clicca qui
Amici della Fattoria , è in arrivo una intervista a sorpresa , chi sarà l'intervistato ???
__________________________________________________________________________________________
Spostato il luogo del concerto di Trento da Piazza Duomo al parco del Palazzo delle Albere - polemica sul cachet
Bob Dylan in giugno a Trento
con i soldi della Provincia

TRENTO. Bob Dylan suonerà a Trento il 16 giugno, ma non in piazza Duomo.
E' questo l'esito del consiglio di amministrazione del Centro servizi
culturali Santa Chiara che ieri pomeriggio si è dichiarato disponibile ad
organizzare l'evento musicale in collaborazione con l'Associazione Arte
giovane di Tione. I problemi di costi, a quanto pare, sarebbero superati
dopo l'intervento del governatore Lorenzo Dellai in persona. Scartata piazza
Duomo, ora si guarda alla zona delle Albere.
E' stato, quello di ieri, un consiglio di amministrazione molto partecipato.
Del resto per il Centro servizi Santa Chiara l'occasione di portare a Trento
Bob Dylan è un'occasione ghiotta, da non perdere soprattutto vista la
disponibilità manifestata da Dellai a venire incontro ai costi
dell'organizzazione.
Inutile nascondere che i problemi ci sono. Innanzitutto di costi, a
prescindere da quanto la giunta deciderà di integrare. C'è innanzitutto
l'altissimo cachet chiesto dal cantante per la data trentina: 240 mila euro,
a cui andrà aggiunta qualche altra spesa per l'allestimento del palco. «O i
biglietti copriranno i costi, o se ne farà a meno», ha avvertito nei giorni
scorsi l'assessore alla cultura e vicepresidente della Provincia Margherita
Cogo, rispondendo alla richiesta di garanzie economiche avanzate dal Centro
S.Chiara. Sembrava una pietra tombale sul concerto, ma a riaprire la partita
ci ha pensato all'indomani il presidente della Provincia Lorenzo Dellai. Al
Centro Santa Chiara, ieri, hanno fatto due conti: per sperare di coprire i
costi ci vorranno almeno seimila persone paganti, con un costo del biglietto
che varia tra i 40 e i 50 euro. Ci sono da aggiungere, però, gli altissimi
costi dell'allestimento del palco e degli spazi per il pubblico, oltre a
quelli legati alla pubblicità dell'evento. Quanto serve? Ben più dei 240
mila euro di cachet.
L'altro aspetto delicato è quello logistico. Il cda ieri ha bocciato
senza appello l'opzione Piazza Duomo: sei mila persone, lì dentro, non ci
stanno. I tecnici del Centro considerano che l'unico posto in centro adatto
all'evento potrebbe essere il parco del Palazzo delle Albere su cui, ora,
verranno svolti approfondimenti.
Resta da stabilire, infine, che tipo di rapporti debbano intercorrere -
nella gestione delle spese - tra il Centro Santa Chiara e l'Associazione
Arte Giovane. La sensazione è che il Centro cerchi quantomeno una
condivisione delle responsabilità oltre che dei costi, non volendo restare
con il cerino in mano nel caso di un flop dell'evento.
Facciamo due conti veloci : cachet Dylan 240.000 euro - 6.000 persone a 40 euro a testa sono 240.000 euro , a 50 euro sono 300.000 euro , allora , dov'è il problema ?
____________________________________________________________________________________________________________________
Parole nel vento - il nuovo libro di Alessandro Carrera rende omaggio a Bob Dylan clicca qui
____________________________________________________________________________________________________________
Mtv Italia lancia “Rock In Rebibbia” clicca qui clicca qui
________________________________________________
Esce la biografia di Macca
Howard Sounes, che scrisse l’acclamata biografia di Dylan “Down the Highway – the life of Bob Dylan” nel 2001, è ora in procinto di scrivere la storia della vita di Paul McCartney, con l’aiuto dello stesso artista.
L’agente di Sounes ha confermato che il libro coprirà tutti gli aspetti della vita e carriera di Paul –inclusa la sua lotta per il divorzio con Heather Mills ( Lady Mucca , come la chiamano i tabloid Inglesi )- anche se è stato veloce nel precisare che nessun contratto è ancora stato firmato…
( Dean Spencer news )
_________________________________________________________________________________________________________________
FREEWHEELIN' TIME - il libro di Suze Rotolo

Freewheelin’ time è Suze Rotolo di prima mano ,
testimone oculare dei creativi e fertili anni 60, appena prima che il circus
cominciasse a muoversi e Bob Dylan si è transformasse nel padrone della
piosta. Chronicles è la storia del Greenwich village nei giorni prima
dell'esplosione della musica folk , quando Dylan cominciava a mettere in
mostra la sua abiltà , Suze faceva parte del circus accanto a lui.

Una ragazza timida , Suze Rotolo era figlia di comunisti italiani della
classe operaia. Crescendo ai tempi della guerra fredda e durante il
McCarthyismo la sua infanzia era turbolenta, ma Suze ha trovato il suo
spazio nella poesia, nell'arte e nella musica. Nel parco di Washington, nel
Greenwich Village di N.Y. , ha incontrato gli amici che la pensavano come
lei e che erano politicamente attivi. In un caldo giorno del mese di luglio
del 1961, Suze incontra Dylan , un giovane musicista in crescita a un
concerto della chiesa vicina alla riva del fiume . Lei diciassette anni ,
lui venti , erano giovani, curiosi ed inseparabili. In quegli anni furono
insieme, mentre Dylan si stava trasformando da cantante sconosciuto nella
voce della sua generazione.

La storia di Suze Rotolo è ricca aneddoti , le memorie chiare di quegli anni tumultuousi di drammatico cambiamento e di aspettative costantemente in aumento , quando l'arte, la cultura e la politica sembravano essersi messe d’accordo per dare al Paese un vita migliore, più libera, più ricca e più giusta. Scrive della sua partecipazioneal movimento dei diritti civili, l’esasperazionedi essere una donna in una cultura dominata dai maschi. E’ la storia dolce ed intensa di un amore , fino al crollo finale sotto la spinta cui Dylan venne sottoposto dai Media , la storia di una sub-cultura in crescendo che diverrà vitale , comunicando ai giovani quell’eccitazione che si sentiva nell’aria , la storia di un amore e delle lotte per un futuro più luminoso .

Susan Elizabeth Rotolo oggi
( Dean Spencer news )
_____________________________________________________________________________________________________
The mistery of blowing in the wind
chi è il vero autore di "Blowing in the wind" ?
Dai primi anni ‘60 la voce che Dylan avesse rubato “Blowing in the wind” da un cantante sconosciuto di nome Lorre Wyatt, o addirittura avesse comprato la canzone per spacciarla per sua, fu una diceria che avrebbe potuto rovinarlo, se la rivista Newsweek fosse stata in grado di scoprire delle prove a favore della storia!
Poi nel 1974 Lorre Wyatt rilasciò un’intervista a Newstime, più tardi pubblicata anche in Singout, che fece chiarezza una volta per tutte sulla faccenda:
<<Nel settembre del 1962 facevo parte di un gruppo di cantanti chiamati Millburnaires. Cominciai a fare le prove con loro tutte le settimane, ma avevo voglia di dimostrare quanto valevo, cosicché cantassero un po’ delle mie canzoni.
Avevo visto Singout pubblicare testi di molte canzoni di protesta, ma una non riuscivo a togliermi dalla testa: era troppo bella! Volevo cambiare un po’ di parole, sperando di camuffarla il più possibile.
Il 28 ottobre eravamo seduti nel salone di Don Larsen a scambiarci canzoni, e mi chiesero di sentire la mia: ero in panico, avevo in tasca l’originale e anche la mia versione che era scritta per metà. Ho pensato che anche se gli fosse piaciuta non l’avrebbero ricordata e la settimana dopo avrei potuto finire la mia senza che nessuno se ne accorgesse.
Cominciai “How many times… ” e alla fine mi dissero: “Wow, l’hai scritto tu??”, “Certo!” risposi, pensando che tanto non ne sarebbe uscito niente d’importante… decidemmo infine di cantarla il giorno del Ringraziamento.
Quel giorno una battuta inappropriata di un componente della band fece in modo che tutti pensassero che la canzone non fosse farina del mio sacco. Da allora ho detto che MAI più avrei cantato quella canzone.
Qualche giorno dopo a scuola, pressato da parecchia insistenza da parte di un professore sul perché non volessi più cantare una canzone così bella, cercando una scusa valida, sbottai che l’avevo venduta per $1.000.
Mi sentivo una merda!
Alcuni mesi dopo comprai il primo Lp di Dylan e, con mio grande sollievo, constatai che la canzone del “vento” non c’era! Poi, nel gennaio del ’63, sulla via per la scuola, un amico mi disse di aver appena sentito la MIA canzone alla radio!! Ma, cantata dal Chad Mitchell Trio la canzone non ebbe molto successo e io pensai di averla fatta franca…
Quattro anni dopo il mio terapista ascoltava meravigliato la storia di come avevo per caso pescato una delle più famose canzoni di tutti i tempi che era diventata l’espressione regina dell’era di “ We shall overcome “ e perchè non avessi mai detto di averla scritta io !!
“Oh”, disse, “almeno hai dei buoni gusti!”>>.
( by Dean Spencer ) clicca qui
Alla fine della fiera "Blowing in the wind" è accreditata a Bob Dylan e le chiacchiere restano chiacchiere !
_____________________________________________________________________________________________________________________
Oggi parliamo di Francesco DeGregori
Francesco De Gregori (Roma, 4 aprile 1951) è un cantautore italiano.
Il suo stile, simile a quello di Bob Dylan e Leonard Cohen, i suoi maggiori ispiratori, richiama sia le sonorità rock, sia quelle melodiche, sia la musica popolare e, dal punto di vista dei testi, presenta un ampio uso della metafora, spesso di non immediata interpretazione, con liriche di ispirazione intimista, letterario-poetica ed etico-politica in cui trovano spazio riferimenti all'attualità e alla storia, che lo hanno reso uno dei cantautori più importanti dell'attuale scena musicale italiana, insieme a Fabrizio De André e l'altrettanto importante Francesco Guccini è considerato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi.
Biografia
Nato a Roma il 4 aprile 1951, da Giorgio De Gregori, padovano, direttore della Biblioteca Pontificia, e Rita Grechi, insegnante di lettere, venne chiamato in questo modo per ricordare lo zio Francesco, partigiano comandante delle brigata Osoppo con il nome di battaglia Bolla, trucidato a Porzus (Friuli) il 7 febbraio 1945 insieme ad altri partigiani (fra cui Guido, il fratello di Pierpaolo Pasolini) da una formazione partigiana comunista.
Trascorre alcuni anni della sua infanzia a Pescara per poi tornare a Roma sul finire degli anni '50; frequenta il liceo classico al Virgilio, e tra i suoi compagni di classe vi è la figlia di Amintore Fanfani.
Nel 1966, insieme al padre e al fratello Luigi, maggiore di sette anni, si reca a Firenze per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione. Come ha raccontato egli stesso, nel 1966 impara a suonare alla chitarra la sua prima canzone, che è Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, il primo brano scritto interamente da lui è invece la storia di un disoccupato che sale sul Colosseo per avere un lavoro, ma scivola e muore.
Gli inizi: il Folkstudio
È grazie al fratello che iniziò ad esibirsi in pubblico: Luigi infatti, con il nome d'arte di Ludwig, si esibiva ogni settimana al Folkstudio, presentando canzoni tradizionali statunitensi e brani scritti da lui. Un giorno, agli inizi del 1970, Francesco fece ascoltare al fratello una canzone che aveva appena scritto intitolata Buonanotte Nina, i cui accordi erano presi da una canzone di Fabrizio De André ma eseguiti nella sequenza inversa. Luigi la imparò e la cantò al Folkstudio con successo, per cui propose al fratello di andare a cantarla la domenica successiva, cosa che Francesco fece.
Al Folkstudio De Gregori conobbe molti musicisti, tra cui Caterina Bueno (che lo ingaggiò come chitarrista per un tour nel 1971, insieme al chitarrista Antonio De Rose, ed alla quale anni dopo dedicò la canzone Caterina, contenuta nell'LP Titanic), Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Giovanna Marinuzzi (con la quale ebbe un breve flirt citato anni dopo nella canzone Niente da capire), Ernesto Bassignano e Giorgio Lo Cascio.
Per un breve periodo diede vita, insieme a quest'ultimo, ad un duo - Francesco e Giorgio - che per molti versi si rifaceva al duo statunitense Simon and Garfunkel; il loro repertorio comprendeva canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen
Sempre con Lo Cascio e la collaborazione di Antonello Venditti ed Ernesto Bassignano, Francesco si esibiva al Folkstudio in uno spazio del programma denominato "I giovani del folk", divenuta poi la denominazione usata dai quattro per le esibizioni nel resto d'Italia.
Theorius Campus
Alla fine del 1971 De Gregori e Lo Cascio ottengono un'audizione con la It di Vincenzo Micocci: sono stati indirizzati a questa etichetta da Giovanna Marini, alla quale avevano chiesto di metterli in contatto con I dischi del sole (cosa non possibile per il repertorio della casa discografica, molto politicizzato rispetto a quello dei due cantautori).
Durante il provino realizzano una lacca con quattro canzoni: Il partigiano (cover in italiano di The partisan di Leonard Cohen) e Dolce signora che bruci cantate insieme, Ho cercato di dirti cantata da Lo Cascio e Signora Aquilone cantata da De Gregori, e Micocci, colpito dai brani, propone loro un contratto discografico.
Da ricordare che la versione incisa in quest'occasione di Signora Aquilone presenta il testo originale, così come veniva cantato da De Gregori dal vivo, e cioè con il verso
|
|
« ...lui mi disse "fratello, è cattivo come Dio...." » |
|
|
|
che verrà cambiato in:
|
|
« ...è antico come Dio » |
|
|
|
Ma, ancora prima di iniziare, il sodalizio artistico si scioglie: come racconta lo stesso Lo Cascio nel suo volume su De Gregori, i due avevano alcune divergenze sulla realizzazione degli arrangiamenti, però il pretesto per la separazione fu un viaggio premio in Ungheria (ottenuto come retribuzione per la registrazione di uno special televisivo magiaro realizzato a casa di Nanni Loy, a cui Lo Cascio rinuncia (perché in quel periodo sta organizzando il matrimonio); De Gregori propone il viaggio a Venditti (che ha anche lui firmato con la It all'insaputa dei due amici) che accetta, e durante il viaggio i due decidono di costituire un duo (scrivendo insieme la canzone In mezzo alla città), e realizzano l'album Theorius Campus, pubblicato nel giugno del 1972, in cui De Gregori include una canzone, La casa del pazzo, con la musica scritta da Lo Cascio.
Il titolo del disco è in realtà anche il nome del duo (non essendo presenti sulla copertina i nomi dei due cantautori): esso raccoglie alcuni brani già presentati al Folkstudio, tra i quali Signora aquilone e Dolce signora che bruci di De Gregori, La casa del pazzo di De Gregori/Lo Cascio e Roma capoccia di Venditti.
L'album è stato ristampato negli anni successivi anche con il nome di Roma capoccia.
L'esordio solista e gli anni settanta
Spinto dai meccanismi della promozione musicale (perché l'idea fu, in effetti, del cantautore), partecipa al Disco per l'estate con la canzone Alice: l'operazione dà i suoi frutti e permette al suo disco d'esordio di avere un relativo successo. L'idea di partecipare a questo festival volle essere anche una provocazione e derivò dalla tentazione di proporre una canzone del genere accanto alla più tranquillizzante Iva Zanicchi. Alice non lo sa è invece il titolo del primo album da solista di De Gregori, che esce nel 1973. È un disco molto discusso dalla critica per la sua vena ermetica e a tratti incomprensibile. Il De Gregori di questo esordio appare come una presenza fragile (rappresentata da una voce delicata e sognante) e al contempo partecipe delle emozioni che lo coinvolgono. La voce flebile e insieme penetrante intona parole sfuggenti ma al contempo evocative: la storia del XX secolo sembra far da sfondo tanto alle canzoni che più espressamente fanno ad essa riferimento (1940 e più ancora Saigon), quanto alle canzoni di carattere più esistenziale (La casa di Hilde), De Gregori inizia, poi, ad utilizzare uno dei suoi cliché più riusciti, il ritratto femminile (Alice, Irene). Un album molto particolare, musicalmente leggero e insieme complesso, che però non trova consenso tra il pubblico.
Dalla IT, De Gregori passò alla RCA Italiana (con un contratto da 300.000 lire al mese), che pubblicò l'album Francesco De Gregori. All'assenza di un titolo specifico, si è spesso sopperito riferendosi ad esso come all'album della pecora. La copertina (opera di Gordon Fagetter, batterista dei Cyan Three e primo marito di Patty Pravo) ritrae un tipico agnello pasquale con le gambe raccolte a reggere un lungo bastone, che reca in cima, ben visibili, le iniziali di Francesco De Gregori. Il disco continua a presentare, sulla linea del precedente, testi estremamente complessi e introspettivi, essendo nel contempo ancora più sperimentale. D'altra parte, gli arrangiamenti sono decisamente più curati e anche l'esecuzione risulta più riuscita. Spiccano le canzoni Bene, Souvenir, Dolce amore del Bahia, Chissà dove sei e due classici: Cercando un altro Egitto (forse il bozzetto più ermetico dell'ermetismo degregoriano) e, soprattutto, Niente da capire.
De Gregori considerava all'epoca questo il suo disco peggiore:
|
|
« Dopo aver firmato il contratto con al RCA, siamo nel '74, feci il disco con la Pecora, che secondo me è il disco più brutto che ho fatto » |
|
|
(Francesco De Gregori[ |
Il successo
Il grande successo arrivò con Rimmel del 1975, uno dei dischi più venduti del decennio, contenente uno dei suoi ritratti più riusciti, l'omonima Rimmel, storia di un addio freddo e distaccato, Pablo (scritta insieme a Lucio Dalla), Quattro cani e Pezzi di vetro, e proseguì con Bufalo Bill dell'anno seguente.
Sempre nel 1975 collaborò con Fabrizio De André per la realizzazione di Volume VIII, passando un periodo nella sua villa in Gallura. Con il cantautore genovese pubblicò la sua canzone Le storie di ieri e collaborò per le canzoni Oceano (che sarebbe l'enigmatica risposta di De Gregori al perché Alice guarda i gatti, domanda che gli era stata fatta dal figlio di De André, Cristiano), La cattiva strada, Dolce Luna e Canzone per l'estate. Nel corso di un'intervista, De Gregori ha dichiarato che la collaborazione con Fabrizio De André fu abbastanza difficile e quantomeno singolare: i due non si incontravano quasi mai perché mentre De Gregori lavorava all'album di giorno, Fabrizio - alzandosi molto tardi - lo faceva di notte.
Il "processo" al Palalido di Milano
Durante la tournée del 1976, il 6 maggio in una tappa al Palalido di Milano, alcuni ragazzi, appartenenti ai collettivi politici studenteschi salirono sul palco ripetutamente, interrompendo il concerto, per leggere al pubblico loro prese di posizione rispetto agli eventi della lotta politica del periodo e contestarono De Gregori per la contaminazione borghese, le frequentazioni di alberghi lussuosi e soprattutto la strumentalizzazione dei temi cari alla sinistra per arricchirsi. De Gregori, dopo aver cantato qualche canzone di malavoglia e sottotono, abbandonò il palco. Dopo un nuovo tour alla fine dell'anno interruppe temporaneamente la sua carriera per riprenderla nel 1978 con il riuscito De Gregori, album contenente la famosa canzone Generale.
L'anno seguente fu quello della ripresa dei tour col grande successo Banana Republic assieme a Lucio Dalla, e con Ron e i futuri Stadio, e dell'album Viva l'Italia, contenente l'omonima canzone che entrò di diritto tra le canzoni più sentimentalmente nazionali italiane.
Gli anni ottanta
Dopo una pausa De Gregori ritornò nel 1982 con il fortunato album Titanic, a cui seguì il successo de La donna cannone, Q Disc dell'anno successivo.
Ormai annoverato da critica e pubblico tra i maggiori cantautori italiani e soprannominato "Il Principe", proseguì la sua carriera negli anni successivi pubblicando altri lavori di ottimo livello, come Scacchi e tarocchi (1985) - che comprende il noto brano La storia - e Terra di nessuno (1987), contenente Mimì sarà.
Gli anni novanta
Nel 1990, scompaginando le logiche commerciali, De Gregori pubblicò contemporaneamente tre album dal vivo, a cui ne seguì tre anni dopo un altro, Il bandito e il campione, comprendente l'omonimo brano Il bandito e il campione, ennesimo successo di pubblico scritto dal fratello Luigi Grechi.
Prima di questo, nel 1992 pubblicò Canzoni d'amore. Nel 1996 uscì Prendere e lasciare; nel 1997 La valigia dell'attore, da cui è tratta la traccia omonima, unico inedito del disco, che nel 1998 si aggiudicò la Targa Tenco come miglior canzone dell'anno.
Il nuovo millennio
Nel 2001 De Gregori pubblica Amore nel pomeriggio in cui collaborano agli arrangiamenti artisti quali Franco Battiato e Nicola Piovani. Il disco ottiene la Targa Tenco come miglior opera dell'anno a pari merito con Canzoni a manovella di Vinicio Capossela. Nel 2002 pubblica insieme a Giovanna Marini un disco di canti popolari e sociali italiani, Il fischio del vapore, ottenendo una inaspettata affermazione di vendite. Sempre nel 2002 è in tour con Fiorella Mannoia, Pino Daniele e Ron. I quattro si esibiscono nei più bei luoghi italiani, e da questa collaborazione nasce il CD live In tour.
Nel 2003 viene pubblicata la biografia "Quello che non so, lo so cantare", edita da Giunti e curata da Enrico Deregibus. Sempre nel 2003, De Gregori partecipa al film di Bob Dylan Masked and anonymous, in cui canta Non dirle che non è così, versione italiana (ad opera dello stesso De Gregori) di If you see her, say hello (da Blood on the tracks del 1975). Nelle note illustrative della colonna sonora di Masked and anonymous, Dylan lo definisce "la leggenda della musica leggera italiana".
Il cantautore romano ritorna nel marzo 2005 con un album di inediti, Pezzi, che si aggiudica nuovamente la Targa Tenco come miglior album dell'anno, mentre Gambadilegno a Parigi viene votata come miglior canzone dell'anno dai lettori del quotidiano La Stampa. Nel febbraio 2006, a soli undici mesi dall'uscita del suo ultimo disco, De Gregori pubblica un nuovo album, Calypsos, con nove brani inediti. Tra questi Cardiologia - brano in cui, a più di 30 anni di distanza da Pezzi di vetro, il cantautore torna ad usare le parole "Ti amo" - e Per le strade di Roma, un ritratto impietoso della Roma del terzo millennio, archetipo dell'Italia dei nostri tempi, che molti vedono come ispirato a Streets of Philadelphia, pubblicato nel 1994 da Bruce Springsteen.
Nel novembre del 2006 la Sony pubblica una tripla antologia che raccoglie i suoi brani più rappresentativi e che contiene, oltre alla celebre Diamante (pezzo scritto per Zucchero e incluso nel suo album Oro, incenso e birra), un demo del 1979 di Mannaggia alla musica, scritta originariamente per Ron e già presente in versione live nell'album Bootleg, e il b-side del singolo Viva l'Italia, la celebre Banana Republic, cantata senza Lucio Dalla.
A fine 2007 esce un nuovo CD-DVD live dal titolo Left & Right - Documenti dal vivo che racconta per suoni e immagini il tour invernale portato in giro per gli stadi italiani. Tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2008, De Gregori è in tour teatrale. Nel corso dello spettacolo, sono proposte due canzoni appena scritte e ancora inedite, che probabilmente troveranno posto nel prossimo lavoro del "Principe": si tratta di "Finestre rotte", un rock-blues molto vibrato, e "Per brevità chiamato artista", il cui testo può essere accostato a "La valigia dell'attore".
( da Wikipedia )
______________________________________________________________________________________________________________________
Il 68 , Bob Dylan e Alessandro Carrera
Al di là delle questioni ideologiche che vorrei focalizzare brevemente, non si può trascurare il fatto che il '68 non è stato solo un fenomeno cieco di protesta, violenza e rivolta tutto "sesso, droga e rock'n roll", ma soprattutto un tentativo di costruire un mondo nuovo, un'alternativa esistenziale basata sull'arte, sulla musica, sulla poesia. Così, se qualcuno oggi mi chiedesse provocatoriamente ("sai chi erano i Beatles?" canta Gianni Morandi che al '68 ha dato pure un brano, un inno politico come C'era un ragazzo) quali siano i prodotti culturali più significativi della Contestazione, oltre al Libretto Rosso di Mao e alla leggendaria figura del Che, potrei rispondere con una lunga lista definendo l'eredità spirituale del '68 come un nuovo Rinascimento. Stiamo infatti parlando di un fenomeno che non partì - si ricordi - dagli stadi e dalle borgate sottoproletarie, cui peraltro Pasolini ha dato nobile voce; ma fu innanzitutto un atto di rivolta culturale e di poesia.
«La nostra era una rivolta che si richiamava più a Camus e all'esistenzialismo che a Marx» ha spiegato lo scrittore Uwe Timm , uno dei protagonisti del '68 tedesco, sul "Corriere della Sera" del 28 giugno 2007 (pag. 43).
Fra i tanti, grandi nomi che mi vengono subito in mente (il cantore del '68 fu in Italia indubbiamente De André con la sua ballata contro la guerra La guerra di Piero) ce n'è uno in particolare che rappresenta non solo la testimonianza vivente del '68, ma anche l'attualità e la necessità di un nuovo Rinascimento e magari di una nuova contestazione: Bob Dylan. Ecco, Bob Dylan è da solo un buon motivo per giustificare, assolvere e tramandare il fenomeno della Contestazione alle future generazioni, come cura contro ogni forma di malessere sociale e per favorire la rigenerazione di una società vecchia e repressiva attraverso la poesia e la musica. La verità è che se non ci fossero stati il '68 e Bob Dylan, oggi saremmo culturalmente più poveri e totalmente asserviti ad un consumismo feroce che tollera la libertà "usa e getta" ma mette in discussione i principi di libertà sociali e individuali faticosamente conquistati. E forse saremmo già stati ridotti in cenere dalle "loro" bombe atomiche. Grazie anche, e forse soprattutto, a Dylan abbiamo per ora fermato la distruzione del mondo, anche se il ticchettio dell'orologio della fine nucleare continua ad allarmarci. Questo è il risultato del '68 con cui gli occhialuti critici devono fare i conti prima di criticare la Contestazione: la momentanea salvezza dell'umanità che quei milioni di giovani in piazza a Parigi, Washington, Berlino, Roma e - insisto - Praga resero miracolosamente possibile dando poderose spallate all'imperialismo occidentale e alla prigione comunista. Risultati? La fine della guerra e del massacro in Indocina e la caduta del comunismo sovietico, avvenuta venti anni dopo, ma sempre come effetto ritardato della contestazione che portò un forte desiderio di libertà.
È pure comprensibile che la protesta abbia assunto toni, simboli (il
comunismo combattuto a Praga in nome della libertà era il simbolo dei
giovani occidentali che chiedevano più libertà) e significati spesso
contraddittori. In fin dei conti quelli che scendevano in piazza erano in
gran parte studenti liceali influenzabili ideologicamente e portatori di un
"vissuto" individuale, di bisogni e sogni, speranze ed illusioni
apparentemente antitetici al collettivismo e al mito della "massa"
manifestante. Ma io considero questo innesto del privato nel "collettivismo
politico" non come una contraddizione, bensì come un arricchimento del
movimento.
Allora, emblematica della feconda commistione di impegno ed evasione,
cultura e politica, ricerca di libertà individuale e lotta per i diritti di
tutti è certamente la frase "storica" che Dylan, appena ragazzo in cerca di
se stesso e dei suoi ideali, scrive sul fodero della sua chitarra: «L'unica
arma che ammazza i fascisti». E giustamente il bel film appena uscito
in sala, Io non sono qui di Tod Haynes, con una superlativa Cate
Blanchett che (con Christian Bale, Richard Gere e Heath Ledger) interpreta
la sfaccettatura femminile di un personaggio poliedrico come Bob, mette in
evidenza l'importanza storica di un principio di libertà e di cultura che,
naturalmente, non vuole ammazzare nessuno (parliamo di chitarre e non di
pistole), ma convincere e commuovere - anche i fascisti - con la forza della
poesia, cioè della verità.
Ma oltre a consigliare la visione di questo film, in cui l'ansia, anche sessuale, di libertà assume una dimensione intellettuale e politica (l'individuo Dylan si impegna nel pubblico senza trascurare i propri bisogni e pulsioni, ecco le apparenti contraddizioni del "Menestrello" sempre in bilico tra politica e culto dell'Io), voglio parlare di un evento editoriale. Mi riferisco alla monumentale e splendida monografia pubblicata da Feltrinelli: Bob Dylan Lyrics 1962-2001, traduzione e cura di Alessandro Carrera, 1250 pagine - ripeto in lettere milleduecentocinquanta -, 60 Euro, una edizione ricchissima anche di materiali fotografici. Il volume, che consiglio a tutti di non perdere assolutamente (perché, come dichiara Bruce Springsteen, «Bob Dylan ci ha liberato la mente così come Elvis Presley ci aveva liberato il corpo»), presenta due sezioni. La prima, oceanica, è dedicata ai testi di tutte - dico, tutte! - le canzoni di Dylan scritte nel corso di un quarantennio, cioè dagli esordi fino ai primi anni 2000. I testi sono in lingua originale con traduzione italiana a fronte, una traduzione curata da un poeta in proprio come Alessandro Carrera, del quale parlerò tra poco. La seconda sezione più "contenuta" - si fa per dire, 200 pagine! - è una bellissima biografia del "Menestrello" raccontata però attraverso la storia cronologica delle sue canzoni. Una scelta molto felice in quanto è impossibile anche dal profilo biografico distinguere vita e opera artistica di questo geniale cantore del nostro secolo. Un po' come Omero e l'Odissea: dove finisce la storia del poeta comincia quella della sua poesia.
Dicevo del traduttore Alessandro Carrera, nato a Lodi nel 1954, trasferitosi negli Usa da molti anni dove attualmente insegna letteratura italiana presso l'università del Texas. Parlo diffusamente di Carrera perché sono convinto che il lavoro di un traduttore sia di per sé una forma di reinvenzione dell'opera originale: una trasformazione che va ben oltre la trasposizione da una lingua all'altra. Carrera è un poeta e un cantastorie, compone e canta ballate accompagnandosi alla chitarra e all'armonica con vero e proprio spirito "dylaniano". Nessuno meglio di lui poteva dunque entrare nel contesto artistico di un genio a volte anche oscuro come quello di Bob. È utile però ripetere che Carrera lega l'attività artistica a quella di docente di letteratura, il che comporta un grande rispetto filologico per il testo originale. In questo caso il traduttore Carrera sceglie una strada felice evitando la sovrapposizione artistica e limitandosi ad una funzione di chiarificazione e mediazione linguistica.
«Alessandro Carrera conosce la pazienza e la misura che, ben oltre il gesto, giungono a fare della scrittura un evento significativo... In tale universo l'energia semantica è in perenne attività, in atto cioè di continua e sorprendente capacità di trasformazione del senso nelle parole...» Alberto Cappi, "Poesia", Anno X, n. 110, ottobre 1997
Questa «capacità di trasformazione del senso nelle parole»
chiaramente non si riferisce esclusivamente all'opera poetica originale di
Alessandro Carrera (recente la pubblicazione della sua raccolta di liriche
La stella del mattino e della sera, edita da Il Filo), ma anche
alla sua attività di traduttore, in questo caso dei testi delle ballate di
Bob Dylan. Se è vero come è vero che tradurre è un po' tradire, Carrera
riesce a tradire il suo mito Dylan ma restandogli paradossalmente fedele. Mi
spiego: i testi del "Menestrello" presentano una struttura fatta di
assonanze fonetiche e semantiche, di rime baciate, talvolta ripeto oscure,
ancorché spiegate dalla voce o dalla performance live dell'artista, ma di
un'oscurità che improvvisamente s'irrora di una luce misteriosa, interiore.
È la luce di un'anima poetica che vaga nei meandri della mente fino a
trovare la via d'uscita, il senso, ossia l'illuminazione. Carrera fa allora
una scelta drastica, rinuncia a tradire poeticamente l'originale evitando di
ripristinare in italiano la struttura metrica e fonetica. A lui interessa
più che altro il senso narrativo del testo e di conseguenza non
strumentalizza Dylan per far la sua di poesia, bensì è come se
"novellizzasse" l'originale inglese in un italiano senza fronzoli, senza
tentativi lirici, insomma cercando di far capire la canzone trasmettendone
il senso "filosofico", anche a costo di andare a scapito della forma lirica.
Faccio un esempio pratico sulla base della celeberrima ballata Knockin'
on Heaven's Door confrontando testo originale inglese (in rima) e
traduzione italiana in versi liberi:
Mama, take this badge off of me
J can't use it anymore
It's gettin' dark, too dark for me to see
J feel like J'm knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Mama, put my guns in the grond
J can't shoot them anymore
That long black cloud is comin' down
J feel like J' m knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Carrera traduce in un italiano comprensibile anche se poco cantabile:
Toglimi il distintivo, mama,
non mi serve più.
Si fa buio, troppo buio, non ci vedo più.
sento che sto per bussare alle porte del cielo.
Sto per bussare alle porte del cielo
Seppellisci le pistole, mama,
non le userò mai più.
C'è una lunga nuvola nera che arriva,
sento che sto per bussare alle porte del cielo.
Sto per bussare alle porte del cielo
Ho detto del verso e della rima che non corrispondono nelle due versioni,
ma c'è altro da notare in questo breve esempio. In primo luogo la
punteggiatura. Nell'originale inglese essa è totalmente assente, mentre
invece compare nella versione italiana. Viceversa, mentre tutti i versi
inglesi cominciano con la maiuscola, quelli italiani alternano minuscola e
maiuscola. Perché? A mio avviso perché l'intento del traduttore, che ha,
dicevo, tutto il bagaglio lirico ed espressivo nonché la necessaria
esperienza e sensibilità poetica per tentare la versione cantabile,
giustamente si astiene e si eclissa dietro il senso, la semantica del testo
che vuole rendere con estrema chiarezza, costi quel che costi.
Le problematiche legate alla traduzione di Dylan in italiano sono state del
resto spiegate da Carrera in un saggio Del tradurre Bob Dylan in
italiano che qui cito in ampia sintesi (l'edizione integrale è comparsa
sulla rivista "Il Filo"). Mi scuso per la lunga citazione, ma ritengo che
questo intervento di Carrera sia molto importante per qualsiasi traduttore
poiché fa capire tutte le difficoltà da affrontare e risolvere prima di
mettersi al lavoro.
Per chi traduce poesia l’esilio peggiore è quello dal paradiso della
rima. Lì non c’è ritorno o riconquista possibile. Non ci sarà modo di dare a
un’altra cassa armonica le stesse risonanze di quel liuto che era stato
messo insieme con il legno dell’albero edenico. Peggio ancora, poi, se il
Testo da tradurre era originariamente parte di una canzone. Perché in questo
caso il traduttore non dovrà tradurre solo il verso rimato, ma anche la voce
del cantante, la sua intonazione, le sue idiosincrasie vocali, i suoi
silenzi e le sue debolezze, perché tutto concorre al significato di una
canzone, non solo quel che c’è scritto, ma ancor di più quello che nemmeno
si può scrivere.
Bob Dylan, del quale ho tradotto 355 canzoni dall’estate del 2002
all’inizio del 2006 (ora raccolte in Lyrics 1962-2001,
Feltrinelli 2006) è appunto l’incarnazione dell’incubo peggiore che possa
assillare un traduttore: un autore nel quale tutta la scrittura è riassunta
nella voce, anzi nelle voci, perché Dylan ne ha molte, una per ogni fase
della sua carriera, al punto che spesso sembra mutare scrittura solo per
rincorrere le metamorfosi della sua voce. E se una voce non si può mai
adeguatamente trascrivere (autorevoli filosofi hanno così argomentato, in
anni recenti), come si potrà addirittura tradurre?
Il criterio che ho seguito nella traduzione delle Lyrics
dylaniane è stato quello di attenermi contemporaneamente a molti criteri,
senza privilegiarne nessuno e cercando di evitare il più possibile
ostinazioni o partiti presi. Soprattutto, ho cercato "to get it right", di
tradurre cioè con la maggior precisione possibile le espressioni idiomatiche
che, data la loro appartenenza a una lingua così mutevole come l’americano
parlato, sono sfuggite ai traduttori che si sono fermati ai testi degli anni
sessanta o che non hanno potuto spingersi oltre gli ottanta. Al loro
occasionale surrealismo traduttoriale ho spesso sostituito significati che
non erano poi così oscuri, a patto di conoscere l’espressione idiomatica di
riferimento. Non che fosse facile (a volte si tratta di espressioni poco
note anche agli americani), e ammetto di avere lavorato in condizioni
migliori delle loro, se non altro perché avevo a disposizione più passato,
più letteratura critica, più banche dati su carta e in internet, nonché
amici competenti e volonterosi. La preoccupazione di tradurre veramente, e
non di inventarmi una traduzione, mi ha costretto però a ridurre talvolta le
mie ambizioni. Dove ho sentito che potevo osare senza stravolgere il verso,
ho osato. Ma se il prezzo da pagare per una traduzione più poetica e
cantante era, un’altra volta, l’incomprensione di ciò che Dylan
effettivamente dice, allora ho preferito non pagarlo. A traduttori futuri
che vorranno riscrivere Dylan secondo i loro criteri e per i loro fini passo
volentieri la mano. Nel corso di questo lavoro mi sono reso conto che un
traduttore può riscrivere, rimodellare, ricreare, ri-soffrire il páthos
del testo originale, renderlo più fluido nella propria lingua, a volte
perfino migliorarlo, ma che spesso deve abbassare la cresta e limitarsi a
tradurre.
La prima decisione che dovevo prendere riguardava le allocuzioni
affettive come "baby”, "mama”, "daddy”, "honey”, "love”. Ho scartato subito
ogni variante di "bambina”, "bimba”, "dolcezza, "cara” o "tesoro” (a queste
ultime due ho riservato solo un contesto ironico). In inglese si tratta di
termini che non hanno età, non richiamano nessuna classe sociale e a volte
non hanno nemmeno sesso, ma in italiano appartengono unicamente alla lingua
della piccola borghesia o al lessico fortemente codificato del libretto
d’opera primo Novecento e della canzone di consumo. "Bimba dagli occhi pieni
di malia” si ascolta nella Madama Butterfly ma, visto che il
personaggio che canta è un americano, non è detto che non sia un traduzione
di "baby”. "Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora” è stato il tentativo di
Dino Verde e Domenico Modugno di tradurre "Bye, bye, baby” ma, nonostante il
successo, l’espressione non ha avuto presa. In effetti non era nuova, e gli
italiani avevano ancora nelle orecchie alcuni versi di canzoni degli anni
trenta come "Bambina innamorata, stanotte ti ho sognata”. "Tesoro”, "cara” e
"dolcezza”, poi, se non sono ironici (come in "cara mia”) sono semplicemente
orribili, sanno di sceneggiato televisivo mal tradotto. "Amore” va usato con
molta parsimonia, perché in inglese uno può dire indifferentemente che ama
Dio, ama il suo cane o ama la crostata di mele di sua zia, ma in italiano
bisogna andarci piano con l’amore (meglio "amore mio”). La lingua di Dylan,
poi, non è quella della piccola borghesia americana, e in italiano necessita
di uno strato più profondo, popolare senza essere per forza populista;
quello che, se vogliamo restare nell’ambito della canzone, appartiene magari
a Paolo Conte o a Enzo Jannacci.
In realtà la corrispondenza quasi perfetta con "baby” si avrebbe con le
espressioni napoletane "nenna” o "nennella”, purtroppo inutilizzabili perché
non diffuse su tutto il territorio nazionale (e sulla questione dei
possibili apporti dialettali mi dilungherò più avanti). "Ragazza mia” si può
usare se il tono non è troppo dolce. Quanto al maschile, "ragazzi” o "salve
ragazzi” sa di oratorio e di trasmissioni per giovani alla radio negli anni
sessanta, ed è quasi sempre meglio tradurlo con "amici” o "amici miei”. In
definitiva, per trovare l’equivalente di "baby” mi sono letto l’antologia
della poesia popolare italiana curata da Pier Paolo Pasolini nonché la
raccolta di canti italiani curata da Roberto Leydi. L’unico possibile
equivalente italiano, comune a tutti i dialetti e a tutte le tradizioni, è
"bella” o "bella mia”. Ma anche "bella” non va inflazionato. Dylan canta, ha
bisogno di riempire il verso e a questo scopo "baby” va sempre bene. Ma una
volta che il suo testo viene letto, e letto in un’altra lingua, di simili
riempitivi non c’è bisogno. Sulla pagina danno solo fastidio. Da qui la
decisione di compiere un massacro degli innocenti e di eliminare quanti più
"babies” possibile. Ho lasciato "bella”, "bella mia” o "ragazza mia” solo
quando il verso e il senso lo richiedevano. Non l’ho usata neanche una volta
in canzoni piene di "babies” come It Ain’t Me, Babe o
Baby, Stop Crying. Ho lasciato l’espressione in inglese,
invece, quando aveva un effetto fonetico che non si poteva alterare, come in
It’s All Over Now, Baby Blue o in Sugar Baby,
perché "Baby Blue” non si può tradurre con "bambina triste” o "bambina blu”.
Può avere il senso, se si vuole, di "perla dei miei occhi”, ma in realtà non
vuol dire niente di preciso, è semplicemente un effetto della tavolozza
fonetica dell’inglese. Cercare di tradurlo in italiano sarebbe come voler
tradurre in inglese "c’era una volta un bambino piccino picciò”. E una
"sugar baby” non è necessariamente una "zuccherina”.
Certo, qualcosa nel passaggio si perde. Data l’ambiguità di "babe”,
It Ain’t Me, Babe è una canzone rivolta da un uomo a una donna solo
perché la canta Dylan. In realtà può anche essere indirizzata da una donna a
un uomo (così infatti, senza cambiare una virgola, la canta Joan Baez). Per
lasciare la stessa ambiguità in italiano avrei però dovuto concludere ogni
strofa con un verso che non mi piaceva. Invece di "l’uomo che cerchi tu non
sono io” avrei dovuto dire "chi cerchi tu non sono io” con un effetto di
chiusura troppo brusco e dal suono troppo secco. Pazienza per l’ambiguità.
Il secondo problema consisteva nel rendere le espressioni di
movimento come "I am walking”, "down the road”, "down the highway” o "along
the line”. L’archetipo dylaniano è quello di un uomo che cammina lungo il
ciglio di una strada di campagna. È così da I’m Walking Down the Line
del 1962 a Love Sick del 1997, fino alla Ain’t Talking
del recentissimo Modern Times ("Ain’t talking, just walking”; come
a dire: "Parlare non parlo, cammino e basta”), perché è uno degli archetipi
del blues e del country. Ma non è un archetipo italiano, e non è neanche una
forma del moto che la lingua italiana abbia mai dovuto esprimere in quel
modo. L’inglese pone un’enfasi tutta preposizionale (spero si possa dire
così) su movimenti anche minimi che in italiano non può essere resa in
parallelo. Non c’è modo di rendere letteralmente un verso come questo di Jim
Morrison in The End: "And he walked on down the hall”. Bisogna
ricorrere a "proseguì”, "mosse i suoi passi”, "avanzò”, "attraversò”, ma
certo non si può tradurre "continuò a camminare lungo il salone” (per quanto
ci siano esimi traduttori di testi rock perfettamente convinti che se tu non
traduci così vuol dire che non sai l’inglese). Ma torniamo a Dylan e
prendiamo un verso di Black Diamond Bay: "She walks across the
marble floor”. Certo, si può tradurre: "Cammina sul marmo del pavimento”, ma
si sente che non funziona, che in italiano l’espressione suona troppo
generica, troppo meccanica, e che non dà nessun senso di direzione o di
scopo. Diremo allora "attraversa la stanza dal pavimento di marmo” o, più
concisamente, "attraversa la stanza di marmo”? Sì, pur di non usare
"cammina”, perché in italiano non si cammina, si va a piedi. "È mezz’ora che
cammino” va benissimo, perché descrive l’azione fisica e non la
destinazione. Ma "si va a piedi” da Lodi a Milano, come dice la canzone
della bella Gigogin. In italiano si "prende” una strada, si "fa” un certo
tratto di strada, si "percorre una via”, anche, ma non fa parte del nostro
bagaglio storico e linguistico dire di qualcuno che "camminava giù per
l’autostrada”.
Anche perché (a parte il "giù” come traduzione sbrigativa di "down”),
mentre il termine "highway” significa prima di tutto "strada maestra”, in
Italia l’autostrada comincia ad esistere negli anni sessanta e corrisponde a
"motorway”, "freeway” o "tollway” (autostrada a pedaggio). Quando Dylan
parla di "highway” a volte si riferisce alla moderna autostrada, altre volte
alla più antica strada maestra. Quello che Dylan ha in mente, in effetti, è
la nostra "statale” (cosa che Guccini aveva capito benissimo quando ha
scritto Statale 17, la sua canzone di autostop chiaramente
ispirata a Down the Highway), e ancora di più il nostro "stradone”,
dove mi viene in soccorso l’autorità del Bartali di Paolo Conte:
"mi piace restar qui sullo stradone / impolverato, se tu vuoi andare vai” (Dirty
Road Blues, a tutti gli effetti). Oppure, cambiando registro, l’autorità
del Canzoniere di Petrarca. Mi sono scervellato per ore su come
rendere in un italiano vero, non posticcio, non inglesizzato, il primo verso
di Standing in the Doorway: "I’m walking through the summer
nights”, finché mi è venuto in mente che Petrarca aveva già risolto il
problema per me: "Solo e pensoso i più deserti campi / vo misurando a passi
tardi e lenti”. Da cui la traduzione che infine ho adottato: "Misuro coi
passi le sere d’estate”. Ma, proprio perché non dovevo irrigidirmi su
nessuna soluzione, mi sono accorto che il primo verso di Love Sick,
"I’m walking through streets that are dead” doveva risultare il più
possibile ricalcato sull’inglese: "Cammino su strade che sono morte”. Non
per come il verso è scritto, ma per come Dylan lo canta. Nessuna traduzione
può trascurare il modo in cui la voce di Dylan scandisce le parole: "I’m
walking - through streets that are DEAD”. E, giusto perché il richiamo alla
poesia "alta” non è mai fuori luogo quando parliamo di Dylan, aggiungerò che
ho tradotto All Along the Watchtower con Dalla torre di
vedetta (e non, pigramente, con "Lungo la torre di guardia” o simili)
perché una poesia di Mario Luzi raccolta in Onore del vero termina
con il verso: "Tanto afferra l’occhio da questa torre di vedetta”.
Il terzo tormento consisteva nel decidere che soluzioni adottare
riguardo alla rima e alla metrica. Come impostazione generale, ho cercato di
resistere all’ossessione della rima a tutti i costi, e di usarla solo con
prudenza, nei punti chiave, o quando il testo mi urlava nelle orecchie che
la voleva assolutamente. Gli italiani sono stranamente convinti che la loro
lingua abbia meno rime dell’inglese. T. S. Eliot (lo scrive nei suoi saggi
su Dante) era convinto dell’esatto contrario. Certamente una volta
l’italiano era una lingua straordinariamente flessibile, dato il grande
numero di troncamenti e inversioni sintattiche che permetteva (altrimenti
non sarebbe rimasto per due secoli la lingua franca dell’opera). Da quando
però l’italiano si è slatinizzato, modernizzato e linearizzato, queste
libertà si sono molto ridotte, e anzi oggi già troncare un infinito (come
facevano ancora impunemente Mogol e Battisti alla fine degli anni sessanta)
ci sembra una cosa vecchio stile, polverosa se non proprio brutta (De
Gregori ha scritto Sotto le stelle del Messico a trapanar proprio
per prendere in giro la scorciatoia dei troncamenti, e anzi voleva
intitolare la canzone Infiniti tronchi). Io non so se l’inglese
abbia o non abbia più rime dell’italiano. Certamente ha più rime tronche,
ossitone, monosillabiche, e poiché la canzone rock è in gran parte modellata
sul fraseggio dell’inglese, un testo italiano che voglia adattarsi al rock,
evitando troncamenti ormai demodé, finisce per usare quelle poche
parole ossitone che possono essere ficcate in fondo a un verso, oppure le
solite rime morfologiche ottenute con i futuri e i passati remoti dei verbi.
Per carità, è una soluzione alla quale ho fatto ricorso anch’io, e anche
spesso, ma so che è una scorciatoia, un cavarsela con poco (più o meno
l’equivalente delle quinte parallele in musica), e l’ho usata solo se mi
sembrava che non disturbasse troppo, e anzi che si notasse il meno
possibile.
La rima è un orologio interno. È un aiuto per l’ascoltatore che, non
avendo il testo sottomano, sa quando aspettarsi la fine della strofa e,
posto che l’autore del testo abbia lasciato cadere i segnali giusti, anche
la fine della canzone. Ma una canzone resta una canzone anche alla lettura.
A meno di non eliminare la divisione in strofe e spezzare la simmetria dei
versi (come ha fatto ad esempio Giovanni Raboni nella sua traduzione dei
Fiori del male, con un coraggio che non tutti hanno
apprezzato), la stessa forma delle strofe, allineate come tante scatolette,
sembra richiedere a gran voce che l’orologio interno non venga lasciato a
scaricarsi.
La soluzione, almeno per me , è consistita nel lavorare più sulla musica
interna del verso che sulla stampella della rima. Quindi ho utilizzato i
seguenti criteri:
1) Prosa versificata, all’occorrenza ritmata, quando la canzone ha versi
lunghi e una forte spinta narrativa. Non ha senso tradurre in rima e metrica
canzoni come Hurricane o Brownsville Girl. Sono
racconti che bisogna rendere leggibili e scorrevoli, senza l’impaccio di una
struttura verbale appesantita da continui ritorni.
2) Verso libero, in canzoni dove ogni verso ha un’autonomia forte e non
ha bisogno della rima per stare in piedi, come in A Hard Rain’s
A-Gonna Fall o nelle ultime canzoni che sono essenzialmente composte di
one-liners, vale a dire versi singoli di significato compiuto e che
potrebbero essere spostati da una canzone all’altra. Più il verso si fa
aforistico e meno ha bisogno della rima – anche se a volte, se non suonava
sforzata, l’ho utilizzata.
3) Blank verse o versi sciolti, senza rima ma con una
precisa struttura metrica. Dando una struttura metricamente omogenea alla
canzone il bisogno della rima spariva, o si faceva sentire molto meno. Come
esempio posso citare il ritornello di Tomorrow Is a Long Time: "E
solo se il mio amore mi aspettasse, / se sentissi il suo cuore batter piano,
/ se solo si stendesse qui al mio fianco, / tornerei a dormire nel mio
letto”. Sono quattro endecasillabi precisi, e l’unico modo di infilarci una
rima consisteva nell’aggiungere una zeppa: "se sentissi il suo cuore batter
piano nel mio petto”, giusto per far rima con "letto”. Per due canzoni
narrative molto vivaci come Bob Dylan’s New Orleans Rag e
Motorpsycho Nightmare ho usato l’ottonario o il settenario tronco, versi
che in italiano hanno una storia illustre (Rolli, Metastasio, Carducci) ma
che dopo Sergio Tofano e il suo Signor Bonaventura ("Qui comincia
l’avventura / del signor Bonaventura”) sanno di vecchiotto e di comico, e
quindi andavano benissimo per il tono di quelle canzoni. Del resto,
Signor Bonaventura a parte, l’ottonario è una formidabile macchina
metrica, molto facile da combinare e molto trascinante se si riesce a
superare l’effetto cantilena. Ecco la prima strofa di Motorpsycho
Nightmare: "Ho bussato a un podere / per un posto dove stare. / Ero
stanco, stanco morto, / e venivo da lontano. / ‘Ehi, ehi’ dico, ‘voi lì
dentro, c’è nessuno in questa casa?’ / Me ne stavo sui gradini / a sentirmi
giù da cani. Poi arriva un contadino / che credeva fossi pazzo, / che mi
guarda e che mi pianta / il fucile nei calzoni”.
4) Rime occasionali o strategiche, che danno coesione al testo senza
doverlo gravare con consonanze cercate a tutti i costi. Desolation
Row, ad esempio, ha cominciato a funzionare solo quando per ogni strofa
ho inserito almeno una rima con "desolazione”, che è sempre la parola
conclusiva. Per lo stesso motivo, ho consapevolmente inserito una zeppa
nell’ultima strofa di Boots of Spanish Leather. Poiché la rima
"weather / leather”, con l’anticipazione in "—eather” del suono della parola
che è nel titolo, avverte l’ascoltatore che la canzone sta per finire, un
segnale ci doveva essere anche nella traduzione. Dunque ho tradotto "Take
heed of the stormy weather” con "dunque attenta alla tempesta che ti bagna”,
per lasciare la rima con "Spanish boots of Spanish leather”, cioè "stivali
spagnoli, di cuoio di Spagna”. È chiaro che la tempesta "ti bagna”, non c’è
bisogno di dirlo, e infatti Dylan non lo dice, ma lo dice Paolo Conte,
ancora lui, in "Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna / e
abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna”.
5) Rime "naturali”, cioè senza inversioni, all’occorrenza servendomi di
infiniti, futuri e participi passati, ma solo se non sforzavano il verso, se
non alteravano la linearità sintattica. Le ho usate soprattutto nei blues e
nelle canzoni con versi brevi e molto ritmati, vicine alla filastrocca
infantile, in particolare nell’ultima strofa giusto per chiudere in
bellezza.
6) Rima e metrica in struttura rigorosa, quasi a specchio
dell’originale. Mi ci sono avventurato solo poche volte, e proprio perché
ero spinto dall’impulso all’autodistruzione che mi ha fatto passare notti su
My Back Pages e Love Minus Zero / No Limit. Perché
proprio quelle canzoni? Non lo so, l’hanno voluto loro. Nel caso di
Mozambique, invece, l’unica canzone che mi sono permesso di riscrivere,
l’ho voluto io. Non mi è mai piaciuta e me ne sono voluto vendicare, finendo
per metterci molto più tempo a tradurla di quanto probabilmente Bob Dylan e
Jacques Levy abbiano impiegato a scriverla. Ma era anche inevitabile.
Qualunque traduzione che evitasse il gioco delle rime faceva l‘effetto di un
dépliant da agenzia di viaggio.
La quarta necessità consisteva nell’essere più fedeli possibile a
quei momenti in cui Dylan forza, consapevolmente o no, la lingua inglese, in
senso grammaticale e per raggiungere inedite combinazioni di significato.
Gli esempi, numerosissimi, coprono tutta la produzione degli anni sessanta e
la prima degli anni settanta. A partire da Blood on the Tracks, che
esce nel gennaio del 1975, la lingua di Dylan diviene più regolare, più
"scritta”, il che non significa che non riservi sorprese, ma solo che non è
più al limite del non-grammaticale come accade ad esempio nei Basement
Tapes (il cui eloquio è talmente folle che in italiano li potrebbe
cantare solo Jannacci, previa riscrittura nel suo milanese o nel suo
italiano più lunatico).
In Ballad of Hollis Brown troviamo ad esempio I versi "Your
baby’s eyes look crazy / They’re a-tuggin’ at your sleeve”, dove non si
capisce se sono gli occhi del bambino a tirare la manica del padre oppure,
per ellissi narrativa, tutti i cinque figli, anche se in quella strofa non
sono nominati. Per cui ho tradotto: "Il più piccolo ha occhi da pazzo, ti
tirano la manica”, senza pretendere di risolvere un’ambiguità che deve
rimanere tale. Allo stesso modo, in
One Too Many Mornings troviamo costruzioni
grammaticalmente ardite come "An’ the silent night will shatter / From the
sounds inside my mind” o "From the crossroads of my doorstep / My eyes start
to fade”. Difficile qui stabilire se Dylan avesse il
controllo della lingua o se fosse la lingua ad avere il controllo di lui.
Non è facile rendere la stranezza di questi versi, ma qui stranezza e
bellezza sono alleate (non sempre è così) e un tentativo andava fatto, da
cui: "E la sera silenziosa andrà in frantumi / per i suoni che avrò in
testa”, nonché: "Dagli incroci della soglia / i miei suoni si fanno più
fiochi”. Una corrispondenza più precisa si può ottenere in un verso di
Boots of Spanish Leather, nel quale "from the place that I’ll be
landing” sta per "where I’ll be landing”, "quel luogo dove io sbarcherò”. Ma
"that” e "che” possono essere polivalenti tanto in inglese quanto in
italiano, per cui è possibile tradurre "quel luogo che io sbarcherò”. Non è
corretto in nessuna lingua ma rende molto bene l’effetto di possesso fisico
della terra "che” si sta sbarcando.
Il quinto rompicapo era dato dal livello parallelo dell’American English che è costituito dallo slang. Prendiamo ad esempio due versi di Hurricane: "If you're black you might as well not show up on the street / 'Less you wanna draw the heat”. Io ho tradotto: "se sei nero è meglio che neanche ti fai vedere in giro / se non vuoi tirarti addosso la questura”. Qui qualunque traduzione è discutibile, perché "less you wanna draw the heat” potrebbe voler dire "se non vuoi attirare l’attenzione” o addirittura "se non vuoi tirare fuori la pistola”. Ho scartato l’ipotesi della pistola perché, se l’idea è quella di non farsi notare visto che sei nero, allora non è il caso di pensare a tirar fuori la pistola. Ma rimaneva il problema di "heat” [calore] che in senso slang significa ”situazione scomoda o rischiosa” (conosciamo tutti i western o i polizieschi tradotti alla carlona nei quali poco prima di una sparatoria c’è sempre qualcuno che dice: "Qui tra poco comincerà a far caldo”) ma quando è con l’articolo ("the heat”) significa "la polizia”. Dylan usa il termine con lo stesso senso in Subterranean Homesick Blues, dove "Maggie comes… / Talkin' that the heat put / Plants in the bed” non vuol dire "Maggie arriva... / dice che il caldo le ha messo / piante nel letto”, come più o meno hanno tradotto tutti, bensì: "Ecco Maggie... / dice che la pula le ha messo / gli spioni nel letto” ("plants” è slang per "informatori della polizia”). Visto che tre versi prima avevo concluso un verso con un "ancora”, mi sono permesso un’italianizzazione ("questura” invece di "polizia”) per poter finire la strofa con un’assonanza. Quindi ho tradotto: "se non vuoi tirarti addosso la questura”. Altre traduzioni hanno: "a meno che tu non vada in cerca di guai”, chè è senz’altro accettabile, oppure: "se sei nero meglio che non ti si veda neanche per strada / o ti rifilano la patata”, intendendo probabilmente "heat” come "patata bollente”. Ma "trovarsi tra le mani una patata bollente” ha solo una vaghissima parentela con il non cercare guai o non voler attirare l’attenzione della polizia.
La sesta incognita era costituita dai livelli stilistici. In inglese
io posso dire "I made a grievous mistake” oppure "I screwed up”. La prima
frase è di tono più alto, la seconda è un colloquialismo. Ma dicono tutt’e
due la stessa cosa: "Ho fatto un grave errore”, oppure: "Ho proprio fatto
uno sbaglio”. Il problema è che "I screwed up” è molto più colloquiale di:
"Ho proprio fatto uno sbaglio”, e anzi corrisponde anche a: "Ho incasinato
tutto”. Solo che se in italiano dico: "Ho incasinato tutto” faccio ricorso a
un registro che in molte circostanze sarebbe considerato eccessivamente
basso, mentre in inglese "I screwed up” è accettabile anche in occasioni
semi-ufficiali. L'American English ha la grande forza di essere una lingua
dove un livello costamente colloquiale e gergale non è visto come "basso
stile”. L’italiano ha perso in parte quel livello diciamo così "americano”
diventando lingua standard e lasciandolo ai dialetti. Ad esempio, io ho
tradotto "Miss Lonely” di Like a Rolling Stone con "Miss
Malinconia” perché volevo che ci fosse un’allitterazione in italiano
(Mi-ma-li), visto che c’è in inglese (Mi-lo-ly), e perché una di quelle
canzoni degli anni trenta che una volta potevano far piangere le signorine
comincia con "Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia”. Il termine
poteva giocare da controcanto ironico alla "Miss Lonely” della canzone, che
è una borghese di buona famiglia ignara del destino al quale sta per andare
incontro. La "Miss Liceo” degli Articolo 31, nella loro versione rap di
Like a Rolling Stone, va altrettanto bene. Ma quando ho letto sul sito
dylaniano www.maggiesfarm.it la traduzione in romanesco di Michele
Murino, nella quale Miss Lonely diventa "Miss-puzza-al-naso” l’ho trovata
formidabile, al punto di rivedere l’intera mia traduzione in chiave più
colloquiale di quanto non fosse all’inizio (è da lì, per esempio, che mi è
venuta l’idea di tradurre "thinkin’ that they got it made” con "gente
convinta di andare alla grande”).
Però non avrei potuto appropriarmi di una soluzione come "Miss
puzza-al-naso”. L’espressione è accettabile, anzi è perfetta, nel contesto
di una parlata regionale e gergale, ma è troppo bassa per l’italiano
standard, dove apparirebbe stonata. A meno, naturalmente, di non prendere il
coraggio a due mani e riscrivere tutto Dylan in chiave di italiano il più
possibile "basso”. Ma a queste operazioni bisogna avvicinarsi con molta
cautela, perché l’italiano è una lingua che ha troppa storia e troppe
storie. Eduardo De Filippo ha tradotto la Tempesta di
Shakespeare nel napoletano del Seicento con un risultato straordinario, ma
il napoletano del Seicento non era un dialetto, era una grande lingua, che
possedeva tutti i livelli e li poteva giocare tutti assieme. Un tentativo di
"abbassare” costantemente la lingua dylaniana ci porterebbe verso un
linguaggio in ultima analisi povero e costretto a sostituire con un continuo
ammiccare la complessità di significati che in realtà non sa dire.
Nemmeno Pasolini riusciva a mantenere un tono basso costantemente
credibile nei suoi romanzi romani, e Gadda ci riusciva solo perché lo
colorava di sarcasmo e di sapienza multilinguistica. Una fiducia eccessiva
nel tono unicamente "basso” finisce con il tradurre il nome "Georgia Sam”,
che compare in Highway 61 Revisited, con un orrendo
"Bingo-Bongo” (l’esempio non è inventato). Per chiarire: "Georgia Sam” è un
nome probabilmente ispirato a due cantanti blues che in alcune occasioni si
erano fatti chiamare "Georgia Bill” (Blind Willie McTell) e "Georgia Tom”
(Thomas A. Dorsey), e non ha nessuna delle connotazioni offensive e perfino
razziste che invece si ricavano da quel personaggio di una canzonetta
dell’epoca coloniale che parla con gli infiniti come una volta parlava la
mamie di Via col vento: "Bingo Bango Bongo stare bene solo
al Congo non mi muovo no no…”).
E poi, Dylan non è solo un imitatore degli imitatori di François Villon.
In Lay Down Your Weary Tune circolano R. W. Emerson e la grande
innodia protestante, Chimes of Freedom risuona di passaggi alla
Walt Whitman, Mr. Tambourine Man riporta precisi echi di John
Keats, All Along the Watchtower è fatta del libro di Isaia più T.
S. Eliot più Wallace Stevens, Every Grain of Sand sarebbe
impensabile senza William Blake alle spalle, Angelina,
Jokerman e I and I sono ardite costruzioni intertestuali tenute
insieme dall’intero tessuto della Bibbia e scritte nell’inglese più "alto”
che il genere della canzone abbia mai potuto reggere. Del resto, se così non
fosse, se Dylan non fosse anche questo, non esisterebbero le decine e decine
di libri scritti su di lui, né i traduttori di mezzo mondo sarebbero così
ansiosi di spaccarsi la testa per trovare, nella loro lingua, la resa
migliore dei suoi versi."
Condivido in gran parte la nota del traduttore Carrera che spiega bene le
ragioni e i presupposti del suo lavoro sui versi di Dylan. Non sono però
certo della validità degli stessi criteri in generale. Penso che la
struttura, la forma di un'opera vada sempre e comunque rispettata. Al
contrario di Carrera, che la cita a mo' di buon esempio, ritengo pessima la
traduzione de Le fleur du mal di Giovanni Raboni che ha mistificato
e ridotto in cenere il genio poetico di Baudelaire che si esprime in versi
metrici e in rime per un preciso scopo lirico. La forma, diceva Pirandello,
è tutto e - parafrasando il Siracusano - chi non rispetta la forma di
un'opera non fa traduzione ma distruzione dell'originale. Che cosa diremmo
di una Divina Commedia tradotta in inglese in prosa? Come minimo
che è un'altra cosa e che il povero Dante non c'entra niente. E, se mi si
permette la sfrontatezza, tra Baudelaire e Raboni preferisco il primo e
pretendo da lettore italiano una traduzione felice e fedele.
Non è naturalmente questo il caso di Dylan-Carrera, perché qui la traduzione
serve a farci entrare nel background anche psichico del geniale
"Menestrello" con un rispetto semantico - ripeto - che mette il senso del
verso al riparo della forma. Senza considerare il fatto che continueremo
sempre a cantare i testi di Dylan nella versione originale, magari
reinterpretando col tono di voce, il canto e l'accompagnamento musicale, le
emozioni indicibili e soggettive di una canzone che al di là di ogni lirismo
resta espressione di un'esperienza unica e sempre soggettivamente mutevole.
( Enrico Bernard )
_______________________________________________________________________________________________________________
Concierto del año
El poeta del rock
Se consagra Bob Dylan como el rey del Festival Cultural Zacatecas 2008
|
|
|
(fotos: fátima sánchez / IMAGEN) |
Se consolidó
Bob Dylan como el rey del vigésimo segundo Festival Cultural Zacatecas, al
congregar a sus fanáticos en la Plaza de Armas.
En las gradas se encontraron personas de todas las edades, mientras que en
la plancha de la Plaza, jóvenes y sus más fieles admiradores acamparon para
esperar el recital del ganador de del Premio Príncipe de Asturias 2007.
A las 19:00 horas no quedaba hueco alguno y los minutos transcurrieron hasta
llegar las 20:30, cuando el público comenzó a aplaudir para que el músico de
Minnesota y su banda aparecieran en escena.
El momento deseado llegó y el poeta del rock subió al escenario con su
guitarra en la mano, a lo cual los asistentes respondieron con palmas y
gritos.
Posteriormente acudió a su teclado y su armónica, lo que emocionó e hizo que
el público tocara las puertas del cielo.
El
repertorio fue un recorrido por canciones como “Rainy day women”, “It ain’t
me babe”, “Watching the river flow”, “Masters of war”, “Blowin in the wind”
y, la más coreada del concierto, “Like a rolling stone”.
|
|
Los
apasionados de su música no dejaron de elogiar cada acorde, los balcones
aledaños se vieron abarrotados y en una terraza podía leerse sobre una
manta: “Dylan forever young” (Dylan siempre joven).
Ni un sólo abucheo fue escuchado durante la noche, su lugar fue ocupado por
ovaciones y muestras de respeto hacia la leyenda viva más importante del
rock, a quien algunos consideran el Quinto Beatle.
La noche transcurrió y Bob Dylan, según su proverbial costumbre, no
pronunció palabra alguna durante las dos horas de su actuación.
Cuando el cantautor ya se había retirado, el público aplaudió para pedir una
interpretación más, a lo que el poeta del rock regresó y complació con dos
temas más al extasiado auditorio.

( Dean Spencer news )
Intervista ad Al Diesan clicca qui
________________________________________________________________
Dylan suonerà a Madrid in luglio clicca qui
_________________________________________________________________
Dai realizzatori degli acclamati film documentari NO DIRECTION HOME: BOB DYLAN, RIDING GIANTS, DOGTOWN e Z-BOYS arriva AMAZING JOURNEY: THE STORY OF THE WHO, la biografia autorizzata del leggendario gruppo rock. clicca qui
___________________________________________________________________________________________________________
Dicevano.........
Dispiace, ma il
mito è muto
di Walter Gatti
I sessant'anni di Bob Dylan. È stato un grande: però la sua
poetica è troppo legata a una precisa epoca. A differenza dei Beatles che
hanno attraversato mode e stagioni
Mr. Tambourine
man ha sessant'anni. Campane a festa nel mondo della musica e della cultura
lo scorso 24 maggio, quando Bob Dylan, «Il cantautore», l'uomo che ha
trasformato la musica pop in arte, in poesia, in protesta, in romanzo
sociale ha soffiato sulle candeline. L'uomo da cui tutti i cantautori d'ogni
latitudine sono sorti, da Springsteen a De Gregori, da Lucio Battisti a Paul
Simon, l'autore da cui pure John Lennon ha attinto. L'uomo che nel '62, in
piena crisi Usa-Urss ,si prese la briga di scrivere una canzone - Hard rain
gonna fall -sulla morte da guerra nucleare (quando l'unica morte che la
gente era avvezza ascoltare in musica era quella da cuore infranto per
amore); l'uomo che nel '69 mandò a quel paese gli organizzatori del più
grande happening giovanile della rock generation, il festival di Woodstock,
adducendo la sua voglia di tranquillità; l'uomo che si proclamò cristiano e
contemporaneamente ebreo, ma anche palestinese. Sessant'anni, 29 dischi
(evitando di conteggiarne un'altra ventina tra antologie, dischi live e
collection di scarti più o meno pregevoli), una serie quasi infinita di
«nomination»al premio Nobel per la letteratura e di lauree ad honorem. E poi
canzoni, da Blowin in the wind a Like a rolling stone, da Forever Young ad
All along the watchtower, colonne sonore dei vortici dell'epoca
contemporanea, songs indecise tra melodia pura e la necessità di scoccare la
scintilla della coscienza. Insomma un genetliaco che conta.
Peccato che sia un compleanno sentito più che altro dagli over 40, perché
sotto quell'età (purtroppo? per fortuna?) Bob è quasi uno sconosciuto.
Beninteso: chi ha una certa affinità con la cultura musicale pre Spice girls
e Gigi d'Alessio conosce di certo Mr Tambourine e Hurricane, Blowing in the
wind e Like a rolling stone, eppure - la considerazione è d'obbligo - lui,
mister Robert Zimmerman da Duluth, Minnesota, non ha attecchito nella
generazione di chi ama gli Alex Britti e le Britney Spears, o di chi
s'appassiona per Radiohead, Offsprings e U2. La sua latitanza nella cultura
diffusa salta agli occhi quando si raffronta la passione verso Dylan e i
suoi dischi con quella per l'altro nome immortale della musica pop, quello
dei Beatles, noti urbi et orbi, senza differenza di generazione, senza
soluzione di continuità popolare (come dimostra la recente calata di Paul
McCartney a firmar dischi a Milano, con contorno di centinaia di fans under
20 sovreccitati). Attenzione: stiamo parlando dei due pezzi da Novanta del
pop, dei due nomi che più hanno influito (in assoluto) sulla musica rock. Ma
perché una canzone come Imagine continua a passare su tutte le radio del
mondo, mentre la più melodica delle sue canzoni simbolo, Knocking on heavens
door, rimane negli archivi? Come mai i Beatles sono più noti, più amati e
famosi?

Certo ci sono motivi
di freddo marketing. In pratica la differenza tra «industria dylaniana» e
«industria beatlesiana»è abissale: laddove Dylan sfugge intenzionalmente a
ogni programmazione a tal punto che persino sul palco i suoi musicisti
ignorano quale canzone «Il mito»voglia suonare il minuto successivo -gli
strateghi di McCartney e soci programmano ogni minima virgola del percorso
commerciale. E inoltre non si può dimenticare quanto pesi la fortuna che
bacia chi si ritira presto (per non parlare -ma è un discorso di macabro
branding - di chi scompare fisicamente...) e non vive l'onta della
vecchiaia, della mancanza di creatività, dell'appannamento delle idee. Certo
i Beatles si sono sciolti e gli anni successivi alla loro divisione (fino a
oggi) sono stati colmi di rimpianti; questo porta alla beatificazione di
ogni prodotto dato in pasto al mercato come chicca o rarità, come ad esempio
la Beatles anthology, il recente One, la canzone realizzata con il Lennon
clonato, vale a dire Free as a bird. Per Dylan è l'esatto contrario: Bob ha
continuato a produrre dischi spesso al di sotto delle attese, continuando a
esibirsi in tournèe a volte deludenti, in cui - salvo eccezioni - il
pubblico era formato da quarantenni. E mentre autori coetanei - su tutti Van
Morrison, ma anche Neil Young, Leonard Cohen, James Taylor - riuscivano
comunque a farsi ascoltare dagli under 20, lui restava lontano, sfocato,
quasi in ritiro sull'Horeb.
Ma tutto questo non spiega forse l'incidenza sul costume. Come mai su questo
piano Dylan arranca nella sfida con i Beatles? C'è una spiegazione: di
sicuro Bob e i quattro di Liverpool cercavano cose diverse e hanno lasciato
tracce diverse. I Beatles cercavano la perfezione della canzone. Per i
quattro musicisti britannici partiti dal più elementare dei beat e approdati
(con l'aiuto di un certo signor George Martin, musicista sopraffino e
intenditore di jazz e classica) a un certo punto (dopo il concerto di San
Francisco del 29 agosto 1966, all'interno del Candlestick park) divenne
obbligatoria la scelta di ritirarsi dalla vita on the road, dal contatto con
il palco e con il pubblico, per dedicarsi esclusivamente a loro stessi e
alla loro... idea di canzone. Non ne volevano più sapere di pubblico
urlante, di fans che svenivano ai loro piedi. Di colpo John e Paul e Ringo e
George erano diventati grandi e avevano deciso di mollare la vita da star
per dedicarsi ad altro. Ad esempio per dedicarsi a far dischi: erano degli
affamati di cose nuove, avevano mille musiche nelle orecchie e -con anticipo
di qualche decennio -la voglia di realizzare il primo melting pot artistico
della storia musicale. E il primo disco licenziato dopo quella decisione fu
Sgt pepper's lonely hearts club band, vale a dire l'album considerato il
capolavoro assoluto della pop music. Nella loro forma più elementare - come
in Yesterday o in Imagine - o nella loro forma più complessa - come in A day
in the life o in Lucy in the sky with diamonds - i Beatles hanno lasciato a
tutti «la canzone»: qui sta la loro capacità di durare. Dylan aveva altre
idee per la testa: era più interessato alla forma poetica, all'espressione
di parole e concetti nelle forme care al folk e al blues, non aveva ne
l'intenzione, né le qualità, né una guida (come Martin lo fu per i Beatles),
per partire alla conquista di mille nuovi linguaggi musicali. Inizialmente
Bob era il simbolo della rivolta giovane, poi - quando ha intuito che la
cultura radical americana lo voleva sentir cantare a oltranza Master of war
et similia e mal digeriva i suoi trasformismi culturali, sonori, religiosi e
umani - ha rifiutato tutto ciò che lui stesso aveva rappresentato. Cercava
di comunicare miliardi di parole che gli frullavano per la testa (testi
lunghissimi in canzoni magnifiche, ma a volte noiose....), aveva necessità
vitale di esprimere, ma anche la necessità bruciante di non essere
«usato»dalle mode e dai media. Così se la prima fase della sua carriera
(quella di Freewheelin fino a Highway 61 revisited) era stata segnata dalle
canzoni sociali e la seconda coincideva con la sparizione dalle scene, negli
ultimi anni, in cui è emersa una certa incapacità di confermarsi ad alti
livelli di produzione, Dylan ha convissuto con la ricerca di una identità
non replicabile, di un «essere imprevedibilmente Dylan» che lo ha portato a
vivere «senza il suo pubblico», a esibirsi senza la necessità di farsi
comprendere, come fosse suo obbligo giocare con il pubblico come il gatto
con il topo. Ne è emerso con una paranoia strutturale espressa nella
necessità di vivere sempre in lunghe, estenutanti tournèe (una delle più
lunghe, il Never ending tour, è praticamente durata tre anni, a cavallo tra
il 1988 e il 1990, testimoniata da un appassionante libro di Paolo Vites,
giornalista milanese, uno dei più colti e documentati biografi mondiali del
musicista di Duluth), quasi una edizione riveduta e corretta del personaggio
del dottor Dick Diver, creatura sconvolta dell'indimenticabile Tenera è la
notte di Scott Fitzgerald.

I Beatles cercavano
la canzone perfetta, Dylan no. E infatti sono sempre più rari gli autori
importanti che scelgono Dylan come riferimento e anche album meravigliosi
(Infidels e Oh Mercy) usciti negli ultimi 20 anni non sono riusciti a
ridargli credibilità. Così se è vero che proprio John Lennon indicava in
Dylan, Elvis Presley e Little Richards le persone che più l'avevano
influenzato, è anche vero che tutti i più influenti musicisti delle ultime
generazioni prendono i Beatles a modello, merito anche della loro capacità
sincretica di miscelare, di amalgamare, di sintetizzare stili, ritmiche,
sonorità. «Il mio sogno è riuscire a scrivere piccoli capolavori pop di tre
minuti, come li scrivevano MacCartney e Lennon» ebbe a dire Kurt Cobain,
leader dei Nirvana scomparso suicida. E così come lui si sono espressi Tom
Yorke dei Radiohead, Billy Corgan degli Smashing pumpkins e pure Jeff
Buckley, il songwriter americano che lo stesso Dylan aveva definito come «la
più grossa sorpresa della musica americana degli anni Novanta». Se poi
mettiamo nella partita l'altra grande scuola rock, quella dei Rolling Stone,
maestra di tutti gli outsider da Vasco Rossi ai Guns'n'roses, vediamo che la
canzone d'autore dylaniana, la rockballad d'impianto dylaniano (così come
interpretata da Springsteen o - per venire all'Italia - da De Gregori), è in
ribasso.
Insomma, sarà colpa sua, della sua selvatica incostanza e della sua radicale
svogliatezza, o forse anche eredità dei tempi cambiati fin troppo (tirando
le estreme conseguenze della sua Times they are a-changing) eppure Dylan
oggi è meno vivo - nel gusto, nei discorsi, nella popolarità - di tanti
altri, dei Beatles, ma anche di Celentano, degli Stones di Jagger e
Richards, oppure dei Pink Floyd. Il Dylan dei nostri anni è un musicista che
vive per i suoi show, un tossico cronico, un alcolizzato in pericolo e un
ammalato di sesso «mordi e fuggi». Ma in fin dei conti tutto questo non gli
sembra pesare più di tanto, visto che la sua necessità di incidere, di
essere un riferimento è pressoché scomparsa. «Non so cosa la gente pensi di
me, so solo cosa dicono le case discografiche, i manager e la gente come
loro», ebbe a dire nel 1989 Dylan in un'intervista al Telegraph. In fin dei
conti Bob Dylan non ha avuto (per lo meno dopo la sbornia dei primi anni)
alcun interesse a «rimanere» nei gusti della gente, visto il modo di
rendersi trasparente e inafferrabile che ha deciso di interpretare. La sua è
fobia del successo: si potrebbe fare un parallelismo con il Lucio Battisti
degli ultimi anni, quello della collaborazione anti-canzonettistica con il
poeta-paroliere Panella. Per questo non ha mai rincorso i gusti, le
immagini, le presenze (non ha voluto neppure essere fisicamente presente
alla cerimonia di consegna dell'Oscar per la miglior canzone, che gli hanno
assegnato lo scorso febbraio a Hollywood). E forse proprio per questo perde
la battaglia della popolarità con i Beatles, i suoi amicinemici degli anni
Sessanta. «Non amo essere popolare, preferisco essere me stesso», ebbe a
dire nel '91, alla festa per i suoi 30 anni di attività. A costo di essere
dimenticato...
_____________________________________________________________________________________________
A dieci anni dalla scomparsa di Lucio......il nostro ricordo
Lucio Battisti (Poggio Bustone, 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998) è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei massimi autori ed interpreti nella storia della musica leggera italiana.
La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani: da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica (intesa come susseguirsi di strofa - ritornello - strofa - inciso - finale).
Per ciò che attiene ai testi, grazie alla collaborazione con Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente innovabili, quali il coinvolgimento sentimentale, le gioie e i dolori della vita di coppia, e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana. Ha inoltre saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura, sia su testi di Mogol sia nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella.
Timidissimo fin da ragazzo e letteralmente "attaccato" alla sua chitarra che - attestano i più vecchi amici e colleghi nei gruppi musicali in cui ha militato - era capace di suonare ininterrottamente per ore estraniandosi da tutto, Lucio Battisti si è volutamente trasformato nell'"antipersonaggio" per eccellenza, dopo una discreta gavetta come autore e il successo travolgente come cantante esploso dalla fine degli anni sessanta.
Poco amante dei concerti e delle esibizioni televisive, e refrattario ai tentativi della stampa d'invadere la sua vita privata, a partire dal 1976 Battisti cessa del tutto di concedersi al pubblico, manifestando l'intendimento di comunicare "solo con le sue canzoni" e procedendo con ferrea determinazione su questa strada. Di lì in poi si limita a concedere rarissime interviste a periodici specializzati (l'ultima nel 1982) e a fare qualche sporadica apparizione televisiva fuori dall'Italia. Da un'intervista di quegli anni emerge il suo bisogno di non subire l'onda del successo, capace di travolgere le abilità artistiche del musicista e soprattutto le abitudini di un uomo borghese che non ha alcuna intenzione di cambiare a scapito della sua serenità.
Partito da un background di preferenze musicali costituito da band anglosassoni come gli Animals e i Beatles, ma soprattutto dai grandi del rhythm and blues come Otis Redding, Lucio Battisti affinò negli anni un suo stile personale, fatto di sonorità spesso inattese e innovative (anche se, dalla seconda metà degli anni settanta, influenzate da certo sound d'oltremanica), e di melodie efficaci, mai scontate e piene di sentimento. Ha quindi percorso una strada compositiva che ha saputo coniugare al meglio le sonorità "nere" da lui predilette con la tradizione italiana; un'operazione che a nessuno (se non, limitatamente all'interpretazione, a cantanti come Fausto Leali) era prima riuscita.
Nel periodo artisticamente più felice, le sue melodie si sono perfettamente amalgamate coi testi scritti da Mogol, spesso onirici, all'insegna di un modo di parlare dei sentimenti moderno e coraggioso, in cui le virtù e le fragilità maschili e femminili venivano osservate in profondità con una notevole capacità di analisi introspettiva.
In questo periodo, che durerà fino al 1980, un punto di forza di Battisti è il particolare uso della voce. Dotato di una notevole estensione vocale, Battisti fu criticato per il timbro fuori dai canoni dell'epoca, al punto da essere bocciato ad un provino sostenuto alla RAI all'inizio della sua carriera. Nella sua produzione, Lucio ignorerà le critiche e utilizzerà la sua originalissima voce in maniera "creativa", imponendo un modo di cantare lontano dalla tradizione ma marcatamente italiano. Il suo stile è imperniato su una continua tensione fatta di alternanze tra alti e bassi (emblematica è la canzone Le tre verità, cantata su ben tre ottave diverse), tra apparenti raucedini e acuti in falsetto (come si può cogliere nell'interpretazione della canzone La compagnia), talora facendo ricorso alla velocissima scansione di più sillabe in pochissime battute, per certi versi anticipatrice del rap.
Dopo la separazione artistica da Mogol, oltre a interrompere del tutto ogni forma di comunicazione col pubblico, imprime una svolta alla sua musica, apprezzata da molti critici ma poco compresa e condivisa da larga parte del suo pubblico. I testi, affidati a Pasquale Panella, si fanno criptici, ermetici, densi di giochi di parole e di doppi sensi; le sonorità diventano più elettroniche, col dominio assoluto di una sezione ritmica sempre più orientata verso la musica techno; il canto diventa impersonale, con la quasi totale scomparsa degli acuti, delle raucedini, e dell'alternarsi di toni alti e bassi.
Battisti e la politica
A differenza di quanto accadrà negli anni sessanta e settanta per la gran parte dei cantautori italiani, nella dimensione artistica di Lucio Battisti l'impegno politico non assunse mai particolare rilievo. Battisti fu anzi all'epoca spesso criticato per la scelta di parlare solamente di sentimenti, o delle piccole cose del quotidiano, ritenuta espressione di un approccio "piccolo-borghese". Addirittura, non mancò chi lo indicava apertamente come fascista, in contrapposizione al gran numero di cantautori emergenti dell'epoca vicini alla sinistra o a movimenti anarchici. Tutto questo non senza dare corpo a voci, mai provate, secondo cui Battisti avrebbe anche finanziato organizzazioni di estrema destra.
Pierangelo Bertoli una volta dichiarò come "negli anni settanta si sapeva che Battisti stava a destra e che era vicino al MSI. Non c'era bisogno di prove, lo si sapeva e basta".
La tesi fu alimentata anche dalle discutibili interpretazioni di alcuni versi dei suoi più celebri pezzi: il celebre "o mare nero, mare nero" in La canzone del sole, o "planando sopra boschi di braccia tese" da La collina dei ciliegi, secondo alcuni avrebbero un significato strettamente politico, chiaramente da riferirsi al mondo fascista; persino la canzone Il mio canto libero fu ritenuta a suo tempo una metafora dell'innalzarsi dell'ideologia di destra. Altre canzoni, come La luce dell'est, furono accusate di essere apertamente anticomuniste e antisovietiche.
In realtà, va ricordato che nell'epoca in cui nacquero queste interpretazioni, l'autore dei testi di Battisti, sicuramente da lui condivisi, era Mogol, un autore politicamente disincantato ma all'epoca molto sensibile a temi come l'ecologia, lontani dalle priorità della destra neofascista. Mogol comunque propose a Battisti anche temi quali la fragilità maschile, agli antipodi rispetto a quel mondo politico-culturale. Se per alcuni Battisti era vicino al movimento hippy e alla beat generation, negli ultimi anni Bruno Lauzi ha asserito che invece il cantautore aveva una certa simpatia per Marco Pannella e i Radicali. Alcuni critici, anche negli anni ottanta e novanta, non hanno mancato di voler rinvenire nei testi di Pasquale Panella, talora al limite dell'esoterismo, un qualche recondito significato politico. La copertina di Cosa succederà alla ragazza, con l'acronimo del titolo "C.S.A.R", fu da alcuni letta come una prova delle simpatie monarchiche di Battisti (CSAR come CZAR è la traslitterazione di "Zar", il titolo attribuito agli imperatori russi).
In ogni caso Battisti si disinteressò sempre della politica attiva. Il solo ideale che egli sosteneva con costanza, come del resto Mogol, pareva essere appunto quello ecologico, in curiosa sinergia peraltro con Adriano Celentano, precursore assoluto della "canzone ecologica". Mogol non mancò più volte di dichiarare come lui e Battisti fossero stati etichettati come fascisti con il preciso scopo di renderli antipatici ad una grossa fetta del pubblico giovane, all'epoca particolarmente politicizzato. I due furono poi accusati di maschilismo per alcune canzoni, fra cui Innocenti evasioni, Il tempo di morire, Dio mio no, Comunque bella, e La canzone della terra, che secondo il movimento femminista proponevano un'ideale di donna datato e tradizionalista.
Con il passare degli anni, mutò gradualmente a sinistra la considerazione verso l'opera battistiana, tanto che i dischi pubblicati da Battisti nel periodo del sodalizio con Panella ebbero un'accoglienza entusiastica da parte di Michele Serra in veste di critico per il quotidiano L'Unità. Il risultato fu che in occasione della morte del cantante nel 1998, nei commenti e nelle interviste pubblicate dai mass media italiani Battisti fu avvicinato un po' a tutte le parti politiche, a dimostrazione di quanto controversa resti ancora la questione.
Mogol dal canto suo è sembrato mettere la parola fine al presunto neofascismo di Battisti in un'intervista al Corriere della Sera del 28 giugno 2005: secondo il paroliere l'origine dell'equivoco ebbe luogo durante un concerto, quando il braccio levato di Battisti per incitare il pubblico a cantare fu scambiato per un saluto romano. Secondo quanto riferisce Mogol, a Battisti non interessava la politica e non andava neanche a votare alle elezioni.
Umanamente Uomo: il sogno

Per guidare verso Napoli sulla A1 all’altezza di Fiano
Romano si allunga da qualche anno a questa parte una bretella
autostradale che sbuca dritta a Monteporzio Catone. Ma solo fino alla metà
dei novanta per dirigerti a sud della Capitale dovevi per forza percorrere
il Gran Raccordo Autostradale, uno striminzita e improbabile superstrada
costrutita nel 1962 che ancora resiste al peso degli automobilisti romani,
una razza a parte. Al km 12 di essa si erge ancora oggi una casermone che
all’epoca della sua costruzione (1960) veniva descritto come ”modernissimo",
“innovativo”. Su di esso svettava, rossa in campo bianco, una bandiera che
recava una scritta semplice ma incisiva. Vi si leggeva: R.C.A che stava per
Record Corporation of America. Ogni estate la nostra macchina, diretta al
Sud, viaggiava veloce a fianco della più grande industria di successi
discografici dell’Italia degli anni sessanta: la RCA, l’etichetta di Rita
Pavone, Gianni Morandi, Gianni Meccia, Sergio Endrigo, Piero Ciampi, Nada,
dei Rokes, di Patty Pravo- la ragazza del Piper-, di Lucio Dalla, Dino, Mal
e dei suoi Primitives. La stessa RCA che in America annoverava tra i suoi
artisti Elvis Presley. Quella RCA d’Italia presso cui approderà nel tardo
1969 con il primo vero, solido, contratto di licenza Lucio Battisti e la sua
Numero Uno, soci il paroliere Giulio Rapeti in arte Mogol e il produttore
Alessio Colombini. Io, mentre la macchina dribblava i cornutoni romani e le
loro scassatissime quattro ruote, ogni qualvolta superavamo l’edificio,
allungavo l’orecchio per carpire un suono, uno che potesse in qualche modo
essere sfuggito ai tecnici in camice bianco che avevo visto tante volte alle
prese con manopole e cursori nelle scene lì dentro girate in colossi della
filmografia mondiale come “Quando dico che ti amo” (1967) o “Il professor
Matusa e i suoi hippies” (1968) o il mitico “Steasera mi Butto” (1969).
Ma il monolite di cemento e ferro non lasciava trapelare alcuna nota e io mi
dovevo accontatare di tornare ad ascoltare la radio e consolarmi con “Per
Voi Giovani”, un programma che snobbava i successi della R.C.A. ma che
puntava forte su Lucio Battisti.
Battisti alla R.C.A. ci era arrivato solo per soldi ed il merito è da
ascrivere tutto ad un fiorentino, Ennio Melis, presidente con mandato di
direzione artistica dalle grandi qualità umane e professionali. Lucio a Roma
non ci voleva proprio andare. Stava benissimo a Milano, ma un pò perchè la
televisione si faceva a Roma, un pò perchè aveva chiaro il proprio percorso
è un pò perchè un reatino a Milano – dice il proverbio- più di dieci anni
non può resistere, appena il contratto con la Ricordi volse al termine, non
esitò a rischiare nuovi rapporti e la frequentazione di persone sconosciute.
La sede della RCA di Roma era stata costruita su un terreno di proprietà del
Vaticano che Melis ben conosceva; il ragioniere, infatti, lavorava alla
segreteria del Vaticano quando, nel 1956, presentò a Papa Pio XII una
proposta a cui sarebbe stato impossibile dire no. La scommessa di aprire una
sede italiana del colosso discografico americano la si doveva infatti
proprio a quel Papa che al termine della seconda guerra mondiale si trovava
nella condizione di poter chiedere agli americani qualunque cosa. E fra un
baratto e l’altro ci scappò anche questa “fabbrichetta” di dischi americana,
ma con personale locale. Ma nel 1955 tutto sembrava languire e si stava
pensando seriamente di mandare tutti a casa. Fu allora che il ragionier
Ennio decide di offrirsi come commissario speciale e rilevare la gestione
della RCA italiana. Tutto questo avvenne proprio un attimo prima che in
America la casa madre non firmasse i contratti con Sam Cooke, Henry
Belafonte e Elvis Presley.
La fortuna aiuta gli audaci, insomma!, no?

Quando Battisti arriva a Roma, la RCA ha già fatto cappotto. Ha sbancato
tutti nei sessanta e ora punta alla qualità. Chi meglio di Lucio che unisce
successi e classe? Ma il cantautore di Poggio Bustone e i suoi amici non
sono proprio tipi simpatici. La prima cosa che il nostro fa è chiedere che
venga costruito un eliporto appositamente per lui. E poi il campino di
calcio che lo renderà simpatico a tutti gli operai che lavorano alle
galvaniche e alle presse. Firmato il contratto monta a cavallo col suo amico
Mogol (paga la casa discografica, naturalmente!) e parte per 15 giorni
modello cowboy alla ricerca dell’ispirazione per il primo album che la RCA
gli distribuirà. Il tutto documentato da un fotografo che ha l’esclusiva. I
più cattivi affermano che i due non si allontanarono mai dalla zona di Roma
Nord, ma questa è l’invidia, si sà!.
Lucio Battisti in studio fa le bizze.
 Le
due sale per registrare, la A e la B, sono le più belle d’Europa e sono
state progettate dagli americani; la sala A inaugurata da Artur Rubinstein
che vi registrò i “Notturni“ di Chopin, quella B – in contemporanea - con
registrazione de “I Watussi” di Edoardo Vianello e i Flippers con il coro
dei 4+4 di Alessandroni e l’orchestra diretta e arrangiata dal m°Morricone.
Ma l’artista riccioluto non è contento e chiede che siano cambiate tutte le
attrezzature della sala B (la sala A lo inibiva!), scatenando il malcontento
tra i tecnici residenti. Solo Melis tiene testa a Lucio che pretende anche
nuovi tecnici, gente giovane, e non i soliti senior in camice bianco. A sua
insaputa (o forse no!) Battisti sovverte, insomma, tutti i metodi di
lavorazione discografica in quel momento in uso in Italia, anticipando, in
qualche modo, il modus operandi delle indipendenti. Alla RCA vengono assunti
per la prima volta dei tecnici camuffati da free lance. L’artista sceglie
fra questi un ventenne che si è appena fatto notare per la registrazione di
“4 Marzo 1943” di Lucio Dalla: Gaetano Ria. Poi, dopo quanto descritto, una
mattina Battisti si sveglia storto, chiama Melis e gli comunica che ha
deciso di lasciar perdere gli studi romani per ripiega sulla Fonorama di
Milano, in Via Barletta. Melis, nonostante gli scazzi con il consiglio di
amministrazione della società, accetta ancora la sfida e dà l’ok a Lucio.
Le
due sale per registrare, la A e la B, sono le più belle d’Europa e sono
state progettate dagli americani; la sala A inaugurata da Artur Rubinstein
che vi registrò i “Notturni“ di Chopin, quella B – in contemporanea - con
registrazione de “I Watussi” di Edoardo Vianello e i Flippers con il coro
dei 4+4 di Alessandroni e l’orchestra diretta e arrangiata dal m°Morricone.
Ma l’artista riccioluto non è contento e chiede che siano cambiate tutte le
attrezzature della sala B (la sala A lo inibiva!), scatenando il malcontento
tra i tecnici residenti. Solo Melis tiene testa a Lucio che pretende anche
nuovi tecnici, gente giovane, e non i soliti senior in camice bianco. A sua
insaputa (o forse no!) Battisti sovverte, insomma, tutti i metodi di
lavorazione discografica in quel momento in uso in Italia, anticipando, in
qualche modo, il modus operandi delle indipendenti. Alla RCA vengono assunti
per la prima volta dei tecnici camuffati da free lance. L’artista sceglie
fra questi un ventenne che si è appena fatto notare per la registrazione di
“4 Marzo 1943” di Lucio Dalla: Gaetano Ria. Poi, dopo quanto descritto, una
mattina Battisti si sveglia storto, chiama Melis e gli comunica che ha
deciso di lasciar perdere gli studi romani per ripiega sulla Fonorama di
Milano, in Via Barletta. Melis, nonostante gli scazzi con il consiglio di
amministrazione della società, accetta ancora la sfida e dà l’ok a Lucio.
L’album che si va a registrare non ha ancora un nome, ma chi partecipò alle
sedute le descrive come un inferno. Il m° Giampiero Reverberi che scrisse
delle fantastiche parti per orchestra ne “La Canzone del Sole“ (Nov.1971)
venne relegato al ruolo di semplice “auditore”, lui che aveva fino a quel
giorno svolto funzioni di produttore di sala (si pensi a “Senza Orario,
Senza Bandiera” dei New Trolls con i testi di Fabrizio De Andrè) mentre
vennero richiamati alcuni musicisti di fiducia: a Simon Luca, Dario Baldan
Bembo, Mario Lavezzi (del gruppo “Flora, Fauna & Cemento” prodotti da
Battisti), Oscar Prudente e Tony Cicco, giovanissimo batterista de la
“Formula Tre” (anch’essi della Numero Uno) si chiede di essere a
disposizione ventiquattro ore al giorno. Nessuna deroga, nessun permesso
concesso.
Al termine delle sedute - Battisti aveva intanto lavorato molto tempo da
solo in studio, una cosa che diventerà normale negli anni a venire – che
erano state dichiarate, fin dal primo giorno, off limits, vengono convocati
per un “ascolto ufficiale“ in sala, il presidente Melis e Mogol, il
paroliere e amico del cantautore al quale era stato però, intanto, vietato
anche a lui l’accesso. Racconta Gaetano Ria “in studio l’atmosfera è fredda,
tesa, innaturale. Parte la musica: Mogol, sigaro acceso, spaparanzato nel
comodo divano in fondo alla regia, ascolta concentrato. Al termine della
lettura del nastro nessuno osa parlare e Melis, da sottile mediatore quale è
sempre stato, rivolgendosi a Mogol chiede: “Allora Giulio, che ne dici?...
“. Mogol, stacca il toscano dalle labbra, sputa per terra il tabacco rimasto
appiccicato ad esse e esclama senza staccare la testa dal pavimento” Lucio,
bella cagata!”. Poi, si alza e se ne va, lasciando sul banco di regia un
foglio con un testo scarabocchiato a mano. Lucio Battisti a quel punto,
nell’imbarazzo generale, con calma metodica e senza far trasparire alcun
sentimento si avvicina al registratore master Studer a 2 piste, svita il
nastro appena ascoltato e lo srotola nel cestino della immondizia. Poi si
volta e se ne va uscendo dalla parte opposta, ma dopo aver recuperato il
foglio lasciato di Mogol. Il presidente Melis che ha intanto atteso che la
scena si svolgesse, chiama a se il suo assistente, Grandis (anche lui
fiorentino), e gli mormora nell’orecchio “Segna il titolo: umanamente uomo.
Il sogno “. Poi anche lui esce di scena”.
Al tecnico non resterà che ricominciare tutto da capo. Solo il giorno dopo,
però, come se niente fosse accaduto, Lucio Battisti torna in sala con i suoi
musicisti e registra una nuova canzone, cantando le parole che Mogol aveva
scarabocchiato, il giorno prima, su quel foglietto, titolo: “I Giardini di
Marzo”. Poi, riassemblato l’album, e senza il consenso di nessuno, lo porta
di persona a Roma e lo consegna alla segretaria di Melis. Infine scompare,
rendendosi irreperibile per diverse settimane a venire.

Lucio Battisti è deceduto il 9 Settembre 1998.
La sede della RCA al km 12 del G.R.A. ha chiuso nel 1999. Adesso è un
magazzino. Ennio Melis si è ritirato negli anni novanta e nel luglio 2003 ha
presentato una proposta alla Rai per produrre un nuovo formato del festival
di San Remo dedicato esclusivamente al prodotto di qualità. Gaetano Ria ha
lavorato per Ernesto de Pascale mixand gli album da questo prodotto “Il
Grande Ritmo dei Treni Neri” di Massimo Altomare e “Hypnodance” del gruppo
omonimo.
Lucio Battisti – Umanamente Uomo: il sogno Dischi Numero Uno ZSLN 55 060 –
distribuzione RCA, Aprile 1972
I Giardini di Marzo / Innocenti evasioni / ... E Panso a Te / Umanamante
Uomo : Il sogno / Comunque Bella / Il Leone e la Gallina / Soganando e
Risognando / Il Fuoco
Massimo Luca – chitarre
Eugenio Guaraia – chitarre
Angelo Salvador – basso
Tony Cicco – batteria e percussioni
Lucio Battisti – chitarre e pianoforti
Dario Baldan Bembo- organo e piano
Oscar Prudente, Mario Lavezzi, Tony Cicco, Babelle, Barbara e Sara – cori
Ed inoltre violini, viole,violoncelli e ocarina
Ascolto in regia e archi: Giampiero Reverberi
Tecnico del suono: Gaetano Ria
Foto di Caesar Monti
Produzione: Lucio Battisti
( Ernesto De Pascale )
Gli Inizi
La prima esperienza in
un complesso musicale è nell’autunno 1962 come chitarrista de “I Mattatori”,
un gruppo di ragazzi napoletani. Arrivano i primi guadagni, ma non sono
abbastanza; ben presto Battisti cambia complesso e si unisce a “I Satiri”.
Roby Matano, cantante e
bassista de “I Campioni”, racconta: “Il nostro chitarrista se n’era
andato dopo la partenza di Tony Dallara per il servizio militare e nel
gruppo che apriva la serata, I Satiri, c’era un ragazzo che suonava bene la
chitarra. Così Lucio si è unito a noi. Nel 1964 siamo andati a suonare in
Germania e in Olanda: un’ottima occasione per ascoltare la musica di Dylan e
degli Animals. Il primo ingaggio di Lucio è stato comunque al Club 84 di
Roma. Lo avevamo soprannominato Cucciolo per la sua aria tranquilla e un po’
smarrita”.
Battisti dimostra subito di
avere le idee chiare e una buona dose di ambizione; suonare in gruppo non
gli piace, così decide di tentare la fortuna da solo a Milano, la “Mecca”
della canzone. Qui, diversamente da molti suoi coetanei che per sbarcare il
lunario accettano lavori alternativi, non si piega a soluzioni di
compromesso e, barricato per settimane intere in una pensione di periferia,
persegue senza distrarsi un unico scopo: prepararsi al meglio in attesa
dell’incontro con un discografico importante.
Nel 1964 Battisti compone assieme a Roby Matano le sue prime canzoni. Ecco i titoli in ordine cronologico.
1)
“Era” Battisti-Matano (con
lo stesso titolo, ma con le parole di Mogol diventerà il successo che
conosciamo);
2) “A cosa serve piangere”
Battisti-Matano (con le parole di Mogol diventerà “Le ombre della sera”)
3) “Se non sai che cos'è un
bacio” Battisti-Matano (con le parole di Mogol diventerà “Uno in più”)
4) “Torno stasera”
Battisti-Matano, inedito
5) “Vogliamo il surf”
Battisti-Matano, inedito
il primo 45 giri di Lucio Battisti, "Per una lira", non aveva il suo volto in copertina. Un importante funzionario di quella che era allora la sua casa discografica aveva sentenziato:"Con quella faccia non potrà mai sfondare". E si era ricorsi ad un compromesso, mostrandolo a figura intera, di spalle, abbracciato a un ragazza, mentre sui due campeggiava la riproduzione di una liretta, monetina già a quel tempo assai rara.
Di queste storie è pieno il mondo della canzone. Tutti prima o poi hanno dato un giudizio avventato. Certo è che agli inizi Battisti sforzava a decollare come cantante, mentre mieteva successi come autore.
Era nato il 5 marzo 1943, a Poggio Bustone, in provincia di Rieti. Con la famiglia si era poi trasferito a Roma. Conseguito il diploma di perito industriale, aveva scelto invece la musica.
A Milano si era unito come chitarrista al complesso dei Campioni, che accompagnavano Tony Dallara, e con essi aveva girato anche l'Europa.
Nel '65 l'incontro determinante con Giulio Rapetti, tra i più noti " parolieri " sotto lo pseudonimo di Mogol. I due trovarono una giusta forma di simbiosi che è durata felicemente per oltre tre lustri.
Nel 1968, con " Balla Linda ", partecipava al Cantagiro, nel 69, in coppia con Wilson Pickett, presenta a Sanremo "Un'avventura".
L'affermazione decisiva arrivava nell'estate seguente, al Festivalbar, con " Acqua azzurra, acqua chiara ".
Ma gli anni di Battisti sono stati gli Anni Sessanta e anche gli Anni Ottanta. Li ha iniziati con un 45 giri con due canzoni di grande successo, " La canzone del sole " e " Anche per te ", incise per la sua nuova etichetta, da lui stesso fondata con alcuni amici e collaboratori, e che porta il nome emblematico di " Numero Uno ".
E lì scandì con una serie impressionante di 8 LP, tutti al primo posto nelle classifiche.
Ha fatto anche l'autore, l'editore e il discografico, dando dei successi a Mina, a Patty Pravo, alla Formula Tre, a Bruno Lauzi.
Caratteristica più unica che rara, ha mantenuto il contatto con il pubblico solo attraverso i suoi dischi e qualche rara intervista concessa alla stampa, ignorando televisioni e concerti. Ha difeso strenuamente la sua vita privata. Ha abbandonato la città e si è ritirato in campagna, in Brianza, dove si è persino allestito uno studio di registrazione personale, il Mulino, prima di scegliere di recarsi in America e quindi in Inghilterra in cerca di un nuovo " sound ".
I suoi LP sono stati sempre il frutto di un lavoro lungo e meticoloso, dove nulla è stato lasciato al caso, nemmeno la copertina. Ma non è stato il lavoro del contabile o dell'industriale, ma piuttosto dell'artigiano, se non vogliamo dire dell'artista.
Hanno spesso avuto costi altissimi, in tempo, in fatica e in denaro, ma il prodotto finale non ha mai tradito le aspettative nè di chi lo aveva realizzato o aveva concorso a realizzarlo, né del pubblico cui era destinato.
Battisti e Dylan
Un'altro
pezzo di Battisti che mi ricorda Dylan è quello che parlava della torta di
panna montata tutta contenta di non essere stata lanciata...
mmm aspetta... non mi ricordo come si chiama...
ah sì mi sembra "Dolce
di giorno", con quell'armonica molto dylaniana... E questa cosa
dell'armonica mi ha fatto anche ricordare che avevo lanciato su "Maggie's
farm" un altro quiz relativo a Dylan ed al grandissimo Lucio Battisti e la
domanda era: quale cantautore italiano, che da giovanissimo frequentava il
"giro" di Battisti, era invitato dallo stesso Lucio (quasi ogni volta che si
vedevano stando alle affermazioni del cantautore in questione) a fargli dei
pezzi di Dylan che Battisti restava ad ascoltare in adorazione?
Risposta: Edoardo
Bennato che dichiarò anche testualmente: "Lucio era colpito da come portavo
l'armonica fissata al collo come il suo idolo Bob Dylan".
Però a questo punto,
per curiosità , mi dici sul newsgroup di Battisti quali canzoni di Lucio ti
hanno citato come probabili rimandi a Dylan? Sono curioso... magari poi
hanno imbroccato anche quella che dicevo io e che ora non riesco a
ritrovare...
La morte di
Lucio Battisti è un grande e profondo dispiacere popolare. Che cosa
significhi "popolo", oggi, non è più ben chiaro. Nel caso, però, è
chiarissimo: significa che molti milioni di italiani di ogni ceto sociale e
di almeno due generazioni hanno cantato le stesse canzoni. C'è una chiave,
in ogni bella canzone e in tante di Battisti, che ci apre e ci scioglie come
fossimo prigioni di burro. ...
Il ricordo di un amore, il primo bacio, la prima automobile, i compagni di
scuola, una vacanza, una chitarra, una tenda, un falò sulla spiaggia, la
classica e - giustamente - sbeffeggiatissima gita in pullman, e su tutto la
giovinezza che sfuma (ad libitum, come era scritto nell'ultima riga
dei vecchi spartiti), e va a morire silenziosa nel letto di un grande
ospedale. ...
Erano gli anni del beat e dei Beatles, seconda metà dei Sessanta. Chitarre,
batterie, capelli lunghi, Battisti ne sbucò fuori perfettamente in linea con
il ritmo dei tempi, ma con una sua inconfondibilità smagliante. Era così
insolito da sorprendere ad ogni canzone, ma così solito da farla ricordare a
chiunque al primo ascolto, e non saprei definire in altra maniera la qualità
del genio nell'evo della riproducibilità tecnica: rimanere unico e insieme
diventare, all'istante, di chiunque. E poi, soprattutto, cantava in
italiano, aiutandoci a metabolizzare davvero, e definitivamente, quel salto
d'epoca, quello scatto di vitalità che Beatles, Stones e Dylan ci avevano
fatto balenare davanti, ma in una lingua ancora poco conosciuta, l'inglese,
che per noi era suono ma non significato.
Le parole di Battisti, invece, si capivano due volte bene. Perché era
italiano e perché le scriveva Mogol, paroliere abilissimo, fantasioso e
"facile" tanto quanto, in parallelo, fiorivano i testi "difficili" dei
cantautori. La biforcazione tra canzonetta e canzone colta fu in quegli anni
netta e anche traumatica, riflettendo la medesima spaccatura tra impegno e
disimpegno che divideva la società e specialmente la gioventù. Di qui (non
certo dal fragile pettegolezzo, ieri nato dalla bigottaggine della sinistra
e oggi scioccamente riecheggiato a destra, che voleva Battisti "fascista")
la solida collocazione di Lucio in un suo mondo a parte, nettamente separato
da quello dei grandi cantautori come De André, Guccini, De Gregori, Dalla,
Vecchioni e più tardi Fossati e Conte. Non è affatto vero che questa
differenza abbia generato, nel pubblico, una qualche discriminazione
(addirittura "politica"!) nei suoi confronti. Ogni ragazzo con chitarra
aveva in repertorio, non appena compiuto il minimo apprendistato del giro di
do, parecchie canzoni di Battisti.
Pure, dentro parecchi di questi surrogati d'arte, di queste contraffazioni
tascabili, qualcosa, spesso, ci afferra per sempre. Battisti ci ha preso,
quasi uno per uno, ciascuno nella propria vita e nella propria storia, così
tante volte da farne, indiscutibilmente, il più grande compositore e
cantante di canzonette che l'Italia abbia mai avuto. La sua misteriosa vita
non ci permette di sapere se questo, umanamente, gli sia bastato. Certo
qualche malumore, qualche insoddisfazione dovette toccarlo, se è vero che,
rotto il sodalizio con Mogol, cercò di alzare tono e ambizioni scrivendo,
con il poeta Pasquale Panella, quattro dischi ostici, cifrati, scostanti
(almeno il primo dei quali, Don Giovanni, resta però un capolavoro assoluto,
con buona pace dei nemici dell'intellettualismo).
Si confermò grande musicista e ineguagliabile cantante (ah quella voce,
quella voce acerba, selvatica, intonatissima, da eterno ragazzino con il
cruccio di vivere), ma non riuscì a ripetere quel sorvolo inarrestabile
sopra ogni casa, ogni bar, ogni automobile, ogni coppia in amore. Le sue
canzoni scritte con Mogol, lo ripeto, sono invece per tutta la vita. Sono
nell'aria, sono aria e suoneranno all'infinito, o almeno per quanto infinita
possa sembrarci la vita, tre minuti di canzone più tre minuti di canzone più
tre minuti di canzone più tre minuti di canzone...
(10 SETTEMBRE 1998)
per pubblicare le tue mail scrivi a : spettral@gmail.it

